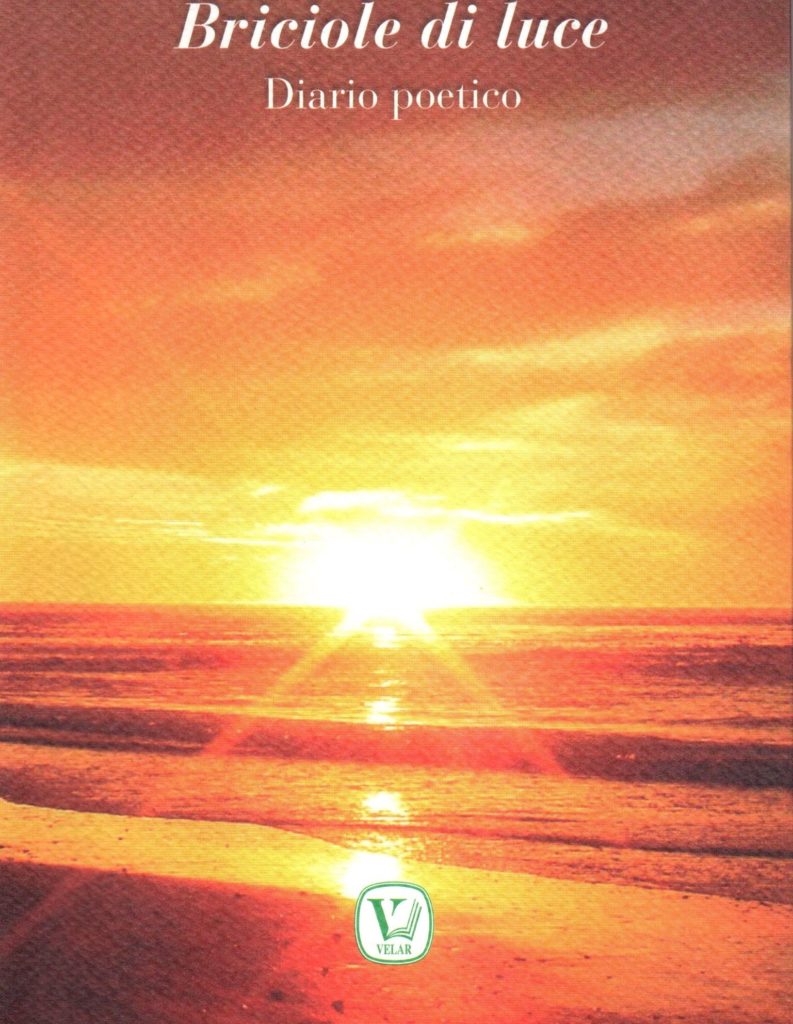Spagnolo, Giovanni, 2021
Briciole di luce. Diario poetico, Prefazione di Mariuccia Lombardi, Gorle, Editrice Velar, 2011, pp. 80, Literary nr. 4/2021.
* In questo testo le citazioni delle poesie si riferiscono al volume Briciole di luce, salvo indicazione diversa.
“Perché la vita non sia un canto inutile”: è la domanda iniziale, e fondamentale, nell’omonima poesia.
Ed è proprio ciò che ci chiediamo, ogni giorno, ogni mattina e ogni sera, quando ci alziamo magari con “occhi pesanti di sonno”, e quando andiamo a coricarci, come precisa il poeta; forse, la mattina meravigliati di esserci ancora una volta svegliati e in procinto di vivere ancora sulla terra, e la sera, riandando a ciò che si è fatto quel giorno. E sospiriamo e preghiamo che la vita non risulti vana, perché non ci sembra importante – giustamente pensiamo così – aver fatto una cosa od un’altra; aver compiuto cose grandi o cose semplici ed umili. In effetti, nel profondo l’uomo aspira ad altro, a qualcosa che sta oltre questa o quella azione, questa o quella realizzazione. Ciò cui aspira è che l’esistere – il suo “canto” – serva a qualcuno, sia “utile” ad altri. Lo dice il poeta, e io lo ripeto: sia utile ad altri.
Ma che cosa significa essere utile?
Come ogni mattina e come ogni sera, si pensa istintivamente alla fine di un tempo e si pensa all’inizio di un altro. Quando finisce un anno, è un momento in cui tutti, o almeno tantissimi, sono a pensare che un tempo è finito. E che cosa vuol dire che un tempo – un anno – è finito? Significa ripresentare al proprio animo il proprio cammino.
Nel cammino della vita – con la vita “nella carne” – ci si ferisce: “porto le tue ferite” (Saluto al ’96). L’anno che è passato, il tempo di questa vita, ha ferito. Non c’è un tempo, vissuto nella carne, che non comporti “ferite”, sofferenze, dispiaceri, persino offese, anzi spesso offese, percosse.
La vita è dolore: la vita nella carne.
Ma è proprio il patire che ci assale, il patire che ci offende, ci percuote è occasione perché andiamo
ai piedi
del Cristo Signore
di legno
[…]
perché la vita non sia inane.
Ovviamente, ai piedi del Crocifisso di legno solo in quanto il Crocifisso di legno è segno iconico di Gesù che ha patito. Ed è ai piedi di Gesù sofferente – e sofferente per noi e in noi! – che ci ritorna la domanda iniziale di Perché la vita non sia un canto inutile:
cosa fare
perché la vita
non sia un canto inutile.
Anche i bei fiori, anche le cose piacevoli e belle, belle e buone, che nel tempo abbiamo avute o compiute, hanno comportato “lacrime e sangue” (Saluto al ’96). Non ci si illuda: un bene che non comporti anch’esso un po’ di sofferenza è assai raro. Ma anche in questo caso noi siamo sospinti dallo Spirante verso il Padre per dirgli, con il Figlio Gesù, il nostro ringraziamento, per fare la nostra eucarestia abituale, nel senso etimologico, sia di eucarestia [da eÙkaristšw. eucharistēo, «ringrazio»], sia di abituale [habitualis, che si esercita come qualcosa che si ha, addosso o dentro, da habēre].
Come qui si vede e soprattutto come si sa per esperienza, la vita non è solo rose e fiori; anzi, rose e fiori lo è assai poco. Però, abbiamo sempre “speranza”: “scaldini di speranza”, dice il poeta (Saluto al ’96), ed è efficace nel far comprendere che la speranza è coltivata in contenitori piccoli ma familiari, proprio come gli “antichi scaldini” delle “mani antiche”. Oh care immagini della giovanile età! Giorni del tepore domestico e della confidenza familiare!
Non a caso a prendere gli scaldini antichi sono mani “use a stringere”, così il poeta, come a tenere stretta e a conservare indefettibilmente la speranza, quegli “scaldini” che hanno dato “calore e vita” all’animo migrante, al perenne pellegrino sulla terra.
Ecco dunque che abbiamo intravisto in che senso la vita può non essere inutile: non è inutile, se essa può dare “calore e vita / al mio cuore”, per dire “che la vita / non muore”.
Il poeta lo dice riferendosi a sé. Certo, egli parla della personale esperienza; ma il proprio vissuto rimanda all’universale in quanto, in arte, è specifico dell’ideazione racchiudere ed esprimere i sentimenti dell’umana esigenza, quando l’arte è poesia e non artificio.
Mi è venuto in mente un episodio. Non so se sia avulso dalla presente riflessione. Un giovane, travolto, ormai da un anno intero, da un suo personale problema esistenziale, pensò di farla finita. Ogni giorno vedeva tuttavia un amico per parlare di cose serie, e anche quel giorno – aveva l’animo nero e il volto contratto – andò dall’amico. L’amico capì. Si parlò come al solito, ma, ad una mezza frase funerea del giovane, l’amico disse semplicemente qualcosa come: ma la vita non muore. Pausa: perciò vale la pena viverla tutta. Il volto si schiarì, l’animo allentò la sua stretta, continuò a vivere e fece ancora molte cose del suo lavoro, e nel suo laboratorio di artigiano riprese a cantare.
La vita non finisce. È questo forse il “mistero” di Primo gennaio 1997?
Forse lo è, nel senso che in ogni tempo che si apre cogliamo il bisogno dell’eternità. Mi spiego: continuare ad esistere, ancora per un anno – anche solo nella prefigurazione, per forza di cose, in quanto l’anno nuovo lo si festeggia, e non lo si festeggerebbe se ci si prefigurasse di non viverlo, ovviamente! –, anche solo per un giorno (“dono inatteso / del giorno nuovo”, Limpido azzurro di Spiragli di luce), anche solo per un’ora, anzi già al primo minuto-secondo di quell’ora è un dono che porta in noi il Donatore. E già, perché non c’è attimo di tempo, cioè non c’è il più minuscolo ente che non sia sostenuto in essere da Dio, l’Essente, l’Io-sono.
E oggi ancora
è dono insperato
incamminarsi
sui sentieri della vita
per approdi luminosi, svanita la notte
di sogni e dolori,
e dilatare il cuore
a nuove speranze,
tra gocce di speranze,
tra gocce di rugiada,
tra rigidi mattini
d’autunno inoltrato (Approdi luminosi di Parole di luce).
Allora si ringrazia “a sera”, ripete il poeta, e poi “sperare / domani / di ricominciare” (Ricominciare).
Il colore della speranza trova nella medesima poesia un precedente, anzi in qualche modo addirittura il presupposto, nella gratificazione goduta da colui che, a sera, spera in un altro domani: la gratificazione degli
Occhi pieni di azzurro e di sole,
dopo aver visto
campi verdi di speranza
e papaveri rossi di amore.
Ancora a sera, “nella penombra della sera”, affidare la giornata e dire grazie al Signore, per gridare, come in Approdo,
[…] la gioia
d’aver visto
un mattino d’agosto
l’aurora – orgia di luce –
inondare il cielo
e capire quanto
hai lottato ed amato
per dare ai tuoi occhi
colore di speranza
e stupore di sogno
Sento echeggiare, letterariamente in forme differenti, lo slancio del «Laudato sie, mi’ Signore», per frate Sole, e «cum tucte le tue creature», sì preziose e belle!
Prima però di inoltrarci in questa interessantissima tematica e ricordando proprio che san Francesco non accenna nel Cantico alle creature animanti ma ne ha dimostrato grande tenerezza – e qui mi limito soltanto a ricordare quell’agnello cui egli era molto affezionato e che egli, prima di lasciare la città di Roma, affidò a «fratello Jacopa», sua amica, come ricordo di sé per il futuro – accenniamo ad alcune espressioni di tenerezza di Giovanni Spagnolo nei confronti di alcuni esseri animati.
Io non avrei saputo soffermarmici, se non ricordassi un episodio che mi capitò, passandovi una vacanza breve, a Cingoli, nell’allora convento dei frati cappuccini. Si trovò una mattina un piccolo d’uccello – che poi si seppe essere una taccola – caduto dal tetto, gli si diede del latte, poi pezzettini di formaggio, più d’uno si premurava all’occorrenza, finché restai solo io ad averne cura, quindi la bestiola si legò a me. Capii soltanto dopo, che si era legata a me, anche perché incominciai a portarla in mezzo all’erba: l’uccellino, che io tenevo appoggiato sulla mano, si fiondava a prendere ogni grillo che saltava. Se si andava a passeggiare per il parco, l’uccello se ne volava via ma ogni tanto tornava sulla mia spalle e, se stavo per dirigermi verso la porta dell’edificio, me lo trovavo difilato sulla spalla, la sera facevo violenza per strapparlo dalla spalla e lanciarlo via dalla finestra – veniva infatti con me nella mia stanza – e la mattina, a qualsiasi ora aprissi la finestra, piombava come un falco (!) sulla spalla. Ho detto che era con me in camera, di giorno. E che faceva? Gli dicevo: «Io devo scrivere. Tu stai buono». Avevo paura che mi spostasse i fogli, mi imbrattasse i libri, mi distraesse. Io avevo bisogno di concentrazione, di silenzio. Il volatile se ne restava dove l’avevo adagiato sul tavolino, dopo un po’ vedevo che chiudeva gli occhi, benissimo, mi dicevo, non mi dà fastidio, così per ore, poi mi alzo e, in qualsiasi momento lo facessi, mi saltava all’istante sulla spalla. Incominciai a nascondermi dietro la porta di una stanza o di un’altra, volava per il corridoio e mi trovava subito, finché provai a giocare a nascondermi in modi più subdoli: mi trovava sempre, e in tempi rapidissimi.
Dopo che lasciai il luogo seppi che era stato ucciso, in città, a sassate da ragazzi. Non ho mai tenuto animali, ma quelli che mi si sono affezionati, in un liceo statale dove insegnavo – cani da guardia –, mi hanno fatto conoscere la delicatezza, la loro percezione degli stati d’animo e il rispetto per come ci si sente al momento. Tutto istintuale, certamente. Ma certamente un istinto fine. L’agnello lasciato da san Francesco alla «signora» amica si comportava con lei come si comportava quando era presente anche Francesco. Ciò è ovvio, per abitudine acquisita dall’animale. Ma anche l’animale può mostrare, pur senza coscienza e deliberato consenso, che cos’è tenerezza. E se può farlo l’animale, non può farlo l’essere umano?
(Insolita parentesi bestiale. I cani lupi al liceo statale, quando passavo davanti a loro, si comportavano in modo diverso a seconda se ero sereno e nella gioia o se ero giù di morale, avvicinandosi più o meno al mio passaggio, mettendomi le zampe addosso oppure no, e così via. Quando mi accorsi che gli studenti mi vedevamo dalla finestra dell’aula, mi venne da dire loro – sapevo che capivano molto bene quello che io avessi comunque detto: così fu sempre, e così per qualunque cosa io dicessi – che erano «animali», erano tutti «asini». Saltarono tutti dalla gioia, molti dicevano: «Sì sì, professore, ci tratti da animali!». Ovviamente, sia io che essi scherzando, ma il dato di fatto era che sia io percepivo il loro stato d’animo prima ancora che dicessero qualcosa, sia essi percepivano il mio, anche se non dicevo alcunché in proposito. Fraternità universale è anche in questo: «invicem praevenientes», capirsi senza neppure parlarsi, e venendosi incontro a vicenda prima ancora di esserne richiesti, praevenientes, come fanno con noi gli «amici» che «ci stanno preparando un posto insieme con loro», senza che noi neppure lo chiediamo e senza che noi neppure ce lo sogniamo).
Giovanni Spagnolo rivela un’attenzione agli animali che s’avvicina a quella nei confronti dei fratelli. Con sensibilità spiccata, come in questa espressione per la “micina” Buffy dai “grandi occhi verdi” (Epicedio per Buffy), venuta a mancare dentro la sua gabbia ‒ “Piango per te, povera Buffy” ‒, come per un’altra gattina, dagli occhi invece “azzurri e grandi” (Resy), che attendeva i familiari “sulla soglia di casa” ‒ “Ora ti piango / nel cuore”. Si badi come il poeta continui a focalizzare gli “occhi”, come si vedrà per tutti gli esseri animanti, come ancora per un povero gatto ammazzato, “dai grandi occhi verdi” (Michelino). Ho parlato, prima, di fratellanza, come “tra amici, / uomini e animali, / finalmente fratelli” (Dino), ma è da notare inoltre l’inserimento di queste creature nella provvidenzialità “di Colui ‘che veste i gigli dei campi / e nutre gli uccelli dell’aria’” (Lamento per Rachele). Se questo preciso richiamo è letteralmente evangelico, il poeta trapassa dalla provvidenzialità universale di Dio nei confronti delle sue creature (quasi “mensa del Signore”, Lamento per Rachele) alla festosità universale delle creature di Dio, in un “paradiso comune / dov’è festa / incontrarsi tra amici” (Dino). Questi concetti, che investono la mente, in ambito lirico vanno giustamente visitati nell’afflato poetico che nasce dal sentimento e rivissuti nella dipintura letteraria che ne scaturisce e che a me pare assai deliziosa e delicata. Quindi un assaggio nel
vuoto […] roseto
dove tu, Nerina,
fedele all’appuntamento,
sentivi i miei passi e
mi accoglievi festante
riconoscendo la voce
in cerca di coccole
[…] (Nerina delle Terme)
Tenerezza, fedeltà e attaccamento sembrano caratterizzare questi esseri come la Rachele che
fedele come sempre,
venivi all’appuntamento
a prendere alla porta
la carità del giorno,
la mensa del Signore.
Ti ricorderò, felice
tra la siepe, abbracciata
ai tuoi cuccioletti già vivaci
nell’orgoglio di lieta povertà
libera sotto il cielo
di Colui […].
Addio […],
riposa tra l’alloro
del giardino abbandonato! (Lamento per Rachele).
Ad essere abbandonato non è soltanto il giardino. Questa è la percezione che il poeta sente anche per sé, per sé e per tutti coloro che hanno beneficiato degli occhi “sprizzanti tenerezza ed affetto” (Michelino): “Ora ogni parola è vuota / per colmare la tua assenza” (Michelino).
Non possiamo esimerci dal toccare, ora, quella tematica che nella poetica di Giovanni Spagnolo è essenziale – e della quale si deve fare imprescindibile cenno per ogni sua silloge –: il tema della natura. Una poesia è da riferire per intero, Attesa e mistero:
Slanciata ed esile
s’erge la betulla
dopo pioggia battente
e mostra fiera
gocce d’acqua
come perle
sospesa a rami vuoti
dense d’attesa
e di mistero
pronte
ad esplodere di luce
se appena
un timido raggio di sole
le avvolge d’amore.
L’attesa, addirittura “vigile” ‒ un leitmotiv di tutta la raccolta poetica di Giovanni Spagnolo ‒, l’attesa che porta con sé, e ad essi conduce, “pensieri stanchi”, può essere anch’essa investita, pur appesantita dalla durezza esistenziale, da “ondate [di] / profumo di gelsomino” che “inonda l’anima” (Profumo di gelsomino di Parole di luce). Si noti come la natura sia partecipe degli stati d’animo umani e come sia carica di “mistero”.
Mistero, qui, indica l’ineffabile – che è prevedibile ma tale che perviene come un dono che non sai quando arriva e soprattutto non sai dartelo tu – ritorno dell’esplosione di “luce”, “esplosione” ricorrente nell’opera di Giovanni Spagnolo altrettanto quanto l’attesa, in un circolare rincorrersi di ritmi interiori. Non esagero nell’accostare le manifestazioni della natura al “mistero” come l’ho qui formulato, se il poeta, in Teofania, si esprime così:
Dono inatteso
agli occhi e al cuore
il vesperale tripudio
bagliore rosa-rosso,
che abbraccia il Resegone
ammantato di prima neve
[…].
E che cos’è questa montagna? Per l’appunto: cos’è? Il “nuovo Tabor”. Se il poeta dice che questo panorama, questa vivente natura, così viva da essere attraversata da bagliori di colori che esprimono sentimenti della nostra umanità – “rosa-rosso”, in questo testo –, allora è davvero qualcosa che, etimologicamente, manifesta il divino (da ϑεο-, teo– e ϕαν-, fan– di ϕαίνομαι, apparire) ed è di conseguenza anche un ristoro per l’uomo, o meglio un antidoto “contro il logorio della vita moderna”, per esprimermi con la nota frase di Ernesto Calindri: “teofania […] / per uomini in corsa”, conclude Teofania.
La manifestazione della natura – soprattutto, secondo i nostri sentimenti sempre un po’ egocentrici – nella sua esplosione di bellezza e amorevolezza è vista abitualmente dal poeta come “mistero” nel senso di dono di Dio (così anche in Vela leggera di Parole di luce) ed è espressa molto spesso con sfumature delicatissime, come in Estasi di Parole di luce:
C’è pace sul lago
appena sfiorato
da carezza di luce.
E il cuore riposa
in tenerezza cullato,
tra le braccia di Dio
in questo universo
d’amore e mistero.
Il mistero come “dono inatteso” della natura creata dà persino il titolo ad una lirica che esprime luminosamente l’osmosi immaginativa tra la realtà naturalistica e la mano, per così dire, che la sorregge nella sua identità ed essere (Dono inatteso di Parole di luce):
Soffice carezza
d’azzurro e rosa
dipinge l’orizzonte
nell’intrecciarsi
di giochi di luce
quadro stupendo
dipinto dal vivo
da mano invisibile
nel cielo infinito.
Al cuore è grato
dono inatteso
[…]
che spinge l’anima
ai confini del nulla.
Questo pensiero di Giovanni Spagnolo e il relativo lessema sono confermati nella sua esperienza quotidiana, oltre l’immaginario poetico. C’è di più: il “mistero” come “dono inatteso” della natura è persino innestato, in Speranza d’Eterno Parole di luce, nel “luminoso mistero” redentivo, cioè in quello
d’alleluja pasquale
trionfo di vita
speranza d’Eterno.
Ciò avviene, appunto, quando
Esploderanno
[…]
in tripudio
di luci e colori
le ultime gemme
di primavera.
E il giovane cuore
danzerà di gioia
appunto in “luminoso mistero” pasquale.
Il sostanza, nel sottofondo, è posto un collegamento tra la gioia – una gioia semplice e universale, comune e quotidiana, che non ha alcunché d’eroico o di strabiliante, di eccezionale o inimitabile – di una bella giornata di sole e di un bel colore di rosso e d’amore, e l’azione di grazie al Signore. Attenzione: ciò è pur vero, ciò è esperienza semplice e umile di ogni umano, e ciò d’altronde non si discosta dal ringraziare il Signore per un minuto-secondo che ci viene donato. Tuttavia, se ciò che s’è detto è pur vero, Giovanni Spagnolo non oblitera, in Ricominciare, il punto fondamentale, quello che in effetti ci pone in profonda sintonia con il Donante, con il Signore che dona:
per dire:
“sia fatta
la tua volontà”
e sperare
eccetera, cioè quel “domani”.
Dire: “Sia fatta la tua volontà” non è, qui, una formula. Come formula, fa parte del rito; e come parte del rito costituisce un elemento del formulario, rientra nella sfera della preordinazione e si colloca nella natura del costituito. Ciò che fa parte del costituito può essere qualcosa di vissuto intimamente e può non esserlo: perché il costituito abbia l’attualità di esistere, è sufficiente che sia posto in essere effettuale, in questo caso come formulazione, cioè come formula formulata. Con ciò non si vuole delegittimare il rito, intendo la preghiera rituale, in cui compaiono, per esempio, il rendimento di grazia e la preghiera del Pater. La preghiera rituale non solo ha valore, ma ha un grandissimo valore e un significato intrascendibile soprattutto quando è azione comunitaria e compimento della vita del Corpo mistico; ed altrove ho affermato con forza e senza tentennamenti, e qui riaffermo, che il compimento della preghiera rituale e ufficiale non va assolutamente obliterato. Qui si sta solo distinguendo due sfere diverse di azioni.
Dire: “Sia fatta la tua volontà” – ed è lo stesso, anzi è meglio, che sia un dire come voce del silenzio sottile, in risposta alla «voce del silenzio sottile» di Dio – come impulso intimissimo è un puro atto spirituale: fa parte dell’anima-spirito che in unione con e in Cristo nella Spirazione ripete, ancora e sempre: Padre, sia!
Non possiamo qui non andare alla madre di Gesù, la “Madre del sì / senza fine / […] / Madre purissima”. E vale la pena riproporre questo testo di Preghiera di Giovanni Spagnolo, perché carico non di devozionismo di maniera o echeggiante un’enfatizzazione allineata agli ammiratori (i devoti!) di star della canzone, ma di radicamento nella realtà di un cuore di mamma e di donna straziata – pur senza pervenire al crudo realismo di un Tudertino –; una madre e una donna che può compatire, etimologicamente patire insieme,
solchi profondi [che]
scavano l’anima
alla vigilia
di giorni incerti
[…]
Ho detto: patire insieme. Certo, qui il poeta parla di sé o di un qualche altro umano; ma parla di tutti, perché tutti sono scavati, come anche una roccia dal gocciolio quotidiano (non si sa forse che Teresa di Calcutta era afflitta dalla morsa dell’animo?), dai “giorni incerti” di cui è sempre vigilia, giorni che ci fanno vivere con l’animo sospeso, “incerto” anche l’animo! Ebbene, Maria, “Madre del sì / senza fine”, è lei che può additare, sì,
additami tu
sentieri di luce
perché il mio “sì”
interminabile sia
come il tuo
[…].
torni la Vita
mattino perenne
di resurrezione.
Così termina Donami, Madre…, dopo che il poeta ha chiesto “di vedere il Risorto / con i tuoi occhi” e dopo che ha auspicato:
Nelle tenebre del cuore
risplenda
finalmente la luce
di tuo Figlio.
Qui siamo alla resurrezione del Figlio Gesù; ma qui siamo anche all’inizio di un cammino che ci porta all’indietro, perché soltanto da lì noi possiamo incominciare, perché è da lì che ha incominciato Maria e ha incominciato Gesù: dalla morte.
Prima di tutto dalla morte del cuore, dalla sofferenza indicibile. Vediamola. Vediamo che in Romitello
[…] la dolente Madre
offre il suo grembo
al Figlio dei dolori.
L’immagine è nota, è negli occhi di tutti – se non altro grazie all’arte di Michelangelo –, ma quel che il poeta qui dice, in più, è la condizione sua propria, quella di se stesso. Però, parlando di sé, il poeta in filigrana rappresenta Gesù (perché così è la poesia, se è vita e non artificio cerebrale), che gli ha
dato appuntamento
nel sangue
[…]
su di un talamo
tra il verde
odorante di pini
e l’azzurra distesa
di cielo e di mare.
Il quadro poi congiunge il “sangue” – di chi, l’abbiamo fatto capire – e la Madre dolente.
Come costantemente, Giovanni Spagnolo dice molte cose attraverso i colori, i sapori, le realtà della natura. Ma noi non possiamo scandagliarle se non per esili cenni, dato che il nostro intervento non è che superficiale e vago. Comunque qui non possiamo farlo, perché quella pennellata naturalistica è carica di vissuto troppo intenso, per essere indagato qui. E poi perché dobbiamo abbandonare quel bel verde odorante di pini e quella distesa azzurra di cielo e di mare, per entrare in un’altra pineta o comunque in un altro talamo di alberi e in un’altra distesa, quella dell’ombra e del buio di cielo e di terra: il Getsemani.
Il Getsemani è il “buio dentro” (Attonito sguardo); e il buio dentro mette paura. Se il buio dentro non facesse paura, non sarebbe Getsemani; e se il Getsemani non facesse paura, non sarebbe Getsemani ma sarebbe una cerimonia. Il Getsemani, per Gesù Cristo, è stato il buio totale. Non un buio da barzelletta, un buio per modo di dire o come simbolo. Ma un buio che fa sudare. E sudare sangue. Il buio dentro, nel Getsemani, è quello per cui non sai capire più, non sai capire neppure perché devi morire e neppure perché tuo Padre ti lascia morire. Non solo perché nessuno ti sta più attorno e se qualcuno che ti sta vicino si mette a dormire, ma perché il Padre sembra fare lo gnorri – Elì, Elì, lemà sabactàni? (a prescindere dal momento in cui è stato collocato il lamento). Ben è vero:
Non ci resta
che il corpo a corpo,
Signore (Agguato).
Non bisogna scandalizzarsi se nel Getsemani quasi si perda la testa, se ci si arrovelli, se si gridi: perché quest’esito, perché questo momento? “[…] / interrogando l’Eterno”! (Viandante di sempre). E si resti “mendico ed attonito” e si cerchi di “fuggire”, “lo sguardo / intento a fuggire”: non vorresti che le cose vadano così (Attonito sguardo).
Il Getsemani dell’uomo è il momento più alto in cui si deve avere la più alta comprensione dell’uomo.
Lì c’è Gesù.
“Eppure brillano le stelle”, continua immediatamente Attonito sguardo. Si passa subito, qui, all’altra faccia del “buio”, all’esito del Getsemani, nel presupposto che si sia detto: «Sia»! Ho voluto deliberatamente la reiterazione, per enfatizzare questo «Sia», cruciale, basilare, fondamentale e fondativo di cui s’è detto qualcosa prima. Ed ora vediamo fondativo di che cosa.
Ma, prima, torniamo su quell’uomo di cui ho detto: è il suo momento più alto. Perché? È il più alto, perché è quello in cui il patire raggiunge il suo culmine – e non è, il culmine, la crocifissione con la tortura e lo strazio del corpo: il dolore fisico, anche estremo, si può superare stringendo i denti (e ci sono anche tecniche psicologiche per saperlo praticare), mentre il buio interiore totale comporta la perdita di ogni risorsa psicologica e mentale. Ma è anche il più alto, perché è lì, in quel buio, che si genera la resurrezione. E allora
l’unico baluardo
il tau nel cuore (Viandante di sempre).
Una volta accolto il tau, è aperta la via della resurrezione: resurrezione, che non è quella del singolo, quella di colui che ha detto «Sia», «avvenga!». È la resurrezione «di molti», perché per molti avviene il Getsemani e per molti avviene l’«avvenga!». Affinché, nel mondo degli spiriti, sia posto in essere tutto, occorre un accoglimento – quello che s’è detto e di colui di cui s’è detto – e occorre una donazione.
La donazione di sé:
Salirò anch’io
[…]
[…] in offertorio (Ascensione)
[e] ne faccio korbàn
di una vita
ai margini […]
confuso […]
a sperare […] (Korbàn).
La nostra donazione non può essere, si sa, che inevitabilmente povera cosa, quindi “come l’umile vedova” – il corsivo è mio –, “ai margini”, “tra gli ultimi”, “con la fine / che incalza” (Korbàn).
Ma va bene così. Va bene, perché
Questo “sì”
che gronda
sangue e luce
non sai ancora
quali e quanto frutti
fecondi ed irrighi.
Né immagini
di quanta gioia
a sera
stipino i granai
gli inutili servi
dell’evangelio(Vigilia).
Ecco l’esito finale del cammino. Ecco dove conducono il Getsemani, il tau e il «Sia! Avvenga così».
E allora, nel mondo, Danzare la vita:
Giorni bui
lastricati d’assurdo
cospargere di luce
[…].
E ad ogni sera
seminare a piene mani
speranza e gioia
[…]
poi a piedi nudi
[e a mani nude! – io aggiungo sempre]
danzare la vita
[…]
per dire all’universo
che ci sei.
Non è richiesto dalla presente lirica introdurci al versetto che è nel Padre (nostro), la preghiera indicata e insegnata dal Figlio. Una cosa però, qui, si può dire: che il testo che stiamo leggendo non inferisce che il soggetto in causa presuma di saperla e poterla fare, lui, la «tua volontà». Inferisce che sia accettata la «tua volontà», cioè che sia consentita intimamente in unione al Volente (dico così, per non usare il termine astratto).
Il che non fa concludere che l’essere umano non possa far niente che riguardi il divino volere: può molto, può tutto, ma soltanto in tanto in quanto è nel suo potere, cioè seguire le indicazioni che il Signore gli ha date. E ciò è già tanto. E ciò è già tutto. Poi basta: poi può fare nient’altro. Poi dunque non importa come si sia snocciolata la vita. Non importa, non già nel senso che, comunque sia andata la vita, è lo stesso per noi, è lo stesso per gli altri: come sono andate le cose, non è lo stesso per noi e non è lo stesso per gli altri. Invece intendo dire che non importa, se tutto ciò che è già stato – e tutto ciò che è e persino tutto ciò che sarà! – è apposto nelle mani di colui che può «fare la sua [di Dio] volontà». E chi è colui che può «fare la sua [di Dio] volontà»? Colui che può «fare la sua [di Dio] volontà» è uno solo: solo Dio. Allora dunque: non importa, nel senso preciso che ho detto; non importa che sia, come dice Incoerenza,
[…] poco o nulla
per sbriciolare una vita
in un gioco
d’incoerenza […],
senza fine.
Ma chi può dire di non essere stato trascinato in una infinita – infinita per modo di dire – incoerenza? Chi può dirlo, che non sia incoerente? Poi, sempre a sera, dice Incoerenza – la sera con il “silenzio della notte” dalla fascinazione abissale, se la si passa “vigile” “attend[end]o l’alba” (Mattutino)! – sprofondo nella nullità della mia esistenza; nullità, per quanto attiene alla mia propria vita – e chi non la percepisce così, può lasciar perdere di leggere queste parole di Incoerenza –:
[…]
dietro al tramonto
[…]
che mi restituisce
i miei limiti
come alberi spogli
stagliati
nitidissimi
all’orizzonte.
“[…] alberi spogli” e “nudi rami” sono ciò che “restano”, di tutto un “mattino invernale”, tuttavia sempre
rivolti al cielo
in muta preghiera
sgranando,
invisibile rosario,
gocce impregnate di luce (A volte di Parole di luce).
Chi non riconosce quei limiti o chi spera di potervi andare oltre, non può capire perché, dice Incoerenza,
amo perdere
questa mia vita.
“Fatta di nulla”. Che cosa ho fatto finora?
Qui si capisce perché ho chiamato incoerente chi non capisce l’infinita incoerenza della propria esistenza: non perché la vita di ognuno sia necessariamente tutta e totalmente sbagliata, incoerente; non perché non ci sia chi abbia condotto una vita senza tante incoerenze, ma perché, comunque sia la vita che è stata vissuta e qualunque sia il giudizio degli umani sulla vita di ognuno, se lasciamo guardare la nostra vita da Dio non sappiamo quale vita verrebbe mai fuori! Quale vita ci troveremmo tra le mani sotto gli occhi!
Ma che cosa ho fatto finora, dicevamo.
Ho fatto tanto. Ed è tutto nulla. Ecco perché chi sa bene – o meglio, sente e vive – che la «sua [di Dio] volontà» può porla in essere solo Dio e non altri, solo chi ha questa esperienza può permettersi di vedere la propria vita, cioè la propria incoerenza o nullità, un “frammento d’eterno” (Incoerenza). Nella sua (la «tua, o Dio») volontà la vita è ricomposta e inserita, perché sia Lui, il Signore, a realizzarla nel mondo: per cui la affido “alla corrente del mondo”. E nella corrente del mondo “Ad uno ad uno / tutti ce ne andremo” (Certezza).
Il poeta non rifiuta la vita: sa “d’averla amata”. Ma attenti: “a volte”, precisa.
Perché? Ci sono sempre momenti di “nostalgia”. Siamo sempre lì: l’esistenza non è ad un solo binario. I binari s’incrociano, e sono l’uno ad un polo positivo, l’altro ad un polo negativo. Un elemento del polo negativo è la nostalgia come rimpianto che spunta dalla desolazione. È la nostalgia che nasce nel deserto e dal deserto, proprio come “in un orizzonte d’attesa” (Orizzonte d’attesa di Parole di luce) tipicamente desertico – che fa venire in mente la Fortezza Bastiani di Deserto dei Tartari in cui si spera che il tempo da Kronos si sviluppi in Kairòs –,
a risvegliare
nostalgia sopita
e rimpianti accorati (Orizzonte d’attesa di Parole di luce).
Il tema della nostalgia e quello del deserto si ripropongono, in toni più brucianti, in altra raccolta poetica di Giovanni Spagnolo, poeta della luce oltre la penombra, il poeta del verde solare oltre l’arido deserto. Ma anche qui è d’uopo – così si diceva ai miei tempi, e qui mi piace! – farne cenno.
Deserto non è solo assenza di comunicazione, vuoto di sentimento, sete insoddisfatta di affetto e di fraternità – endiadi, per affetto fraterno. Deserto è anche una condizione – fisica e, qui, psicologica – di assenza di ciò che è stato. Il deserto è la compagnia che non c’è più, come l’acqua che disseta ma ora manca e fa bruciare la gola. Nel deserto risuona la
[…] dolente litania:
ciò che è stato
o avrebbe potuto
essere in questa vita
nel valzer
delle occasioni perdute (Valzer).
L’accento è posto sul negativo, sulla dolente nota, sul perduto; ma non si può non fare anche emergere nella medesima poesia il lato positivo, radioso, quasi trionfante di luminosità, proprio a risaltare che
[…] sprofonda
il cuore
con il tramonto
dietro questi monti
emergenti nitidi
da profondo azzurro
e infinite
sfumature di luce
avvolgono il giorno
[…].
Su questo concetto, che è principalmente esperienza, si tornerà di continuo, nella poesia di Giovanni Spagnolo, perché la vita è un andare tra “luci e ombre / rose e fiori” (Viandante di sempre).
Infatti la vita – in realtà un brano di vita, come si capisce tra le righe di Partire, dove si vede, quasi in affresco o in fotografia, un uomo che “fatica / a levare / gli ormeggi”, e dove si sente il suo affanno nel dover “alzare le vele / e partire” –, scandisce
i giorni
in altalena
di sogni
e speranze.
Così, in Mattino di rugiada
s’affollano in me
[…]
in questo incerto
tripudio […]
[…]
lacrime e sangue
[…]
dubbi e incertezze
in mattini luminosi di rugiada
e freschi di risurrezione.
Il binomio “sogni e speranze”, in congiunzione con l’altro binomio lessicale, “attese e desideri” che assumo da Richiami d’altrove di Parole di luce, traduce la condizione emotivo-pulsionale in tensione progettuale inattuata e di conseguenza segnata dalla sensazione di vaghezza, che poggia su un “altrove”, cioè su ciò che non c’è qui e adesso. In questa situazione pellegrinante – per ricorrere ad un lessema caro al poeta –, cioè interiormente nomadica, il dato certo e sicuro, addirittura preciso, risulta, in un “andare veloce” verso di esso, “l’inesorabile tramonto” – e l’aggettivazione rimarca la datità di ciò di cui qui si parla. Poi mi piace riproporre tutta la lirica, perché le immagini che si snodano mostrano direttamente, ancor meglio dei discorsi, l’avvicendarsi dei sentimenti opposti, tra i raffreddamenti nevosi e il risveglio di mistero, la stasi e la ripresa:
Innevati i pensieri
si svegliano stamani
a ridestare
sogni e speranze
tra stupore d’azzurro
e richiami d’altrove.
Poi riprendere
il cammino
in questo mistero
di attese e desideri
nell’andare veloce
dei giorni verso
l’inesorabile tramonto.
L’animo dunque è in altalena, e alle lacrime e al sangue fanno da contraltare il “tripudio primaverile / di gemme e fiori”, addirittura “freschi di risurrezione”: risorge natura, ed è l’animo che è invitato a risorgere, quasi la natura sussurri che tutto ritorna a fiorire.
Il sentimento positivo si consolida e, direi, quasi si sublima nella connessione, che è temporale ed è anche interiore, con un altro “avvento”, che non è più quello, come nella poesia precedente, del prossimo “tramonto”: è l’Avvento della nascita di Gesù, e questa “attesa di Dio”, che è “frammento d’eternità”, “è luce agli occhi / e gioia al cuore”, in un continuo e “rinnovato stupore”,
mentre all’orizzonte
si stagliano nitide
vette innevate
su sfondo di cielo
limpido e terso (Tramonto d’Avvento di Parole di luce).
Ho riportato il brano, per mostrare come l’atteggiamento si tramuti al pensiero dell’approssimarsi della natività del Signore: l’innevamento da antitesi a vitalità diventa contiguo al “cielo / limpido e terso”.
Questo cambiamento di segno vale anche per l’altro fondamentale e ricorrente vissuto, nella poetica di Giovanni Spagnolo, che è la nostalgia. La nostalgia non è necessariamente un momento di turbamento. A volte lo è, ma essa ha anche risvolti e volti gratificati,
mentre ondate di ricordi
sfiorano la mente
ed è festa
giocare con l’Eterno” (Appuntamento).
Ci sono ricordi e ricordi, intendo non quanto al contenuto, ma quanto all’approccio emotivo. A distanza di tempo – ciò in cui consiste il ricordare, la leopardiana “rimembranza” –, il sentimento partecipe e condiviso genera l’opposto del ricordo afflittivo derivante da uno strappo emotivo. Nel sentimento positivo si ha gioia ed espansione dell’animo, rimembrando, in questo caso di Appuntamento,
l’ospitale oleandro
[…]
fiori smaltati
carezzati dal vento
oltre il recinto
[…].
Nel vissuto della rimembranza espansiva si colloca, spesso, il ricordo della propria infanzia, il tempo in cui il cuore s’espandeva senza coscienza del male, di ciò che intristisce per delusioni e frustrazioni e che qui io inserisco, perché esso ci conduce al pensiero della madre, cui si collega il tempo della prima età e che leggeremo subito dopo. Il ritorno immaginoso all’infanzia si contestualizza in effusione di gioia che amo qui presentare, in “mattini d’Avvento” soffusi
d’azzurro e rosa
[…]
[che] feriscono gli occhi
con lame di luce
e affollano il cuore
nostalgia e ricordi
d’infanzia lontana
con il contorno realistico del presepe in allestimento
di umile muschio
[…]
e cielo stellato
[…] e profumati mandarini
in rinnovato stupore
per il neonato Bambino” (Mattini d’Avvento di Parole di luce).
La gioia si sente, vibrante, e tra presepe e il Bambino ci si riavvicina serenamente al passato felice.
C’è poi un ricordo che vive di una vita tutta sua: un ricordo di qualcuno che, per il solo fatto che ci sia stato, infonde tanto amore da superare il dolore: il ricordo della propria mamma, un “nome” che “nasconde / abissi di tenerezza” (Madre).
Madre significa “sicurezza” – “ormai lontana” però, che vela di tristezza il ricordo – il quale comunque continua, sì, continua, perché il rapporto tra animo e animo mai si dissolve, come invece si dissolve il rapporto tra carne e carne; il “cuore” custodisce l’antica affezione per la mamma alla quale si continua a raccontare di sé “insuccessi e delusioni”, ancora e sempre senza distanza, perché “ti ho dedicato / nel mio cuore” un “altare”, e allora
torno
dinanzi a te
il bambino di ieri
avvolto di luce.
Se nell’animo si conserva chi ci ha amati e spesso con loro ci si intrattiene in solitari colloqui – che fanno tornare in mente le intense comunicazioni foscoliane con gli uomini generosi del passato –, con la propria madre si intrecciano non solo le parole ma anche gli sguardi, quando
i tuoi occhi
madre,
incrociano i miei
io mi chino
sull’altare
[…]
nel mio cuore” (Madre).
Ecco ancora gli occhi!
Il ricordo è nostalgico, ma pieno d’affetto e di ammirazione per
le tue braccia
che accoglievano
sul tuo cuore
lacrime
d’inesprimibile dolore
per nube insidiosa
[…] (Porto sconfinato di Spiragli di luce).
Non c’è amore più vero che sentirsi partecipi della vita di un altro, e in questo caso di un altro che si ama di amore filiale, di un figlio che capisce quello che passa nel cuore della mamma,
per nube insidiosa
che oscura
splendida luce
di occhi limpidi
proiettati
su possibili orizzonti
di unità armoniosa (Porto sconfinato di Spiragli di luce).
Abbiamo già focalizzato il significato dell’armonia che unisce e abbiamo anche visto la portata di questo morire e rinascere; ma ora lo insediamo in un particolare sentimento: quello per cui si vede una mamma, donna di grande pazienza nelle tribolazioni del mondo. Per tal motivo una madre che pena e che ama è “porto sconfinato, con le “tue braccia”: porto sconfinato che ha da avere il fratello per il proprio fratello, quando il fratello prende il posto di una madre, così che «ciascuno manifesti all’altro con sicurezza le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale?», ricordò Francesco d’Assisi, il quale a frate Leone: «dico a te, figlio mio, come una madre […]».
Qui dunque non possiamo non cogliere, ancora, di nuovo, la luce degli occhi, una luce che d’altronde spazia libera, nell’opera poetica di Giovanni Spagnolo. Dico luce, qui, proprio degli occhi: esattamente.
Gli occhi ricorrono più volte, a proposito della madre: E sono mai tristi, né sono vaghi, sono sempre di tenerezza, e sono anche di forte coraggio: vedono il futuro incerto, il presente insidioso. Ma proprio perché mai si rabbuiano di fronte all’incerto e non chiudono le palpebre di fronte al dolore, ma sono “nitidi” – ha detto – nella loro certezza intrepida e perseverante, risplendono di una luce “splendida” – ha detto. E sono “in tripudio di luce” anche l’ultimo giorno, l’ultima ora (M’affretto all’incontro), che il poeta s’affretta a rimembrare, verso cui s’affretta ad andare, ad andare con il ricordo, “con rose rosse e primule gialle” le rose dell’amore profondo e le primule dell’inizio primaverile. Sì, perché da allora è iniziata la stagione del risveglio in cui si attende di nuovo la vita. Il poeta, “tra fughe e ritorni”, “consuma l’attesa” dell’incontro finale, quello della “casa” comune, della casa che è in fondo all’anima nella quale dimora, con Dio che è in noi, la mamma con tutti gli «amici», coloro che ci hanno preceduti e che ci preparano l’accoglienza amorevole tra loro. Sempre nel chiarore il suo volto (“avvolto di luce”), il poeta lo ricorda così, anche “quel mattino”, molto tempo dopo l’avvenimento, quando
il sole
baciava ancora
il tuo
letto candido.
Il figlio ricorderà – egli assicura – “nel giorno dei risorti” ancora il viso materno, quando quindi esso sarà
dolce naufragio
di luce
nel mare dell’Eterno
[e]
rivedrò i tuoi occhi
e il tuo sorriso
madre,
[e allora] di gioia impazzirò
– egli assicura (Naufragio di luce in Parole di luce).
Da allora il figlio si sente “orfano / per sempre” (Orfano per sempre in Spiragli di luce), anche dopo quarant’anni, quando, vivendo ella, oramai nell’“Amore”, prepara qualcosa anche per sé:
l’abito bello
per incontrare l’Eterno (Spazio infinito, inedito, 16 gennaio 2021).
Così sia. E così è.
Alla fin fine, “madre” cos’è? Sul piano psicologico, fondamentalmente è amorevolezza, cura affettuosa disinteressata. La psicoanalisi ha indagato molto, al riguardo, scoprendo che disinteressata, nel proprio profondo, la madre non lo è – però lo può essere il figlio, dopo che la madre è stata materialmente s-legata da lui. Ma non ci soffermiamo su ciò. È stato rilevato che l’amorevolezza, la cura e l’affetto, insomma una forma di amicizia disinteressata è quella tra maestro e discepolo: il maestro non si sente e non si sentirà mai legato, per la natura stessa del suo compito di indicatore di strada.
Questo veloce rilievo sarebbe estraneo, se non si fosse rammentata l’amorevolezza di Francesco d’Assisi verso i frati. Il rapporto era come tra maestro e discepolo? In parte sì, noi oggi diremmo che lo era in senso pieno, ma per lui forse non era così. Per lui, forse, più che maestro egli si sentiva fratello (e qui lascio l’anacoluto così come è venuto sulla penna: mi piace così). La distinzione è importante, perché allora la fraternità fratesca – diciamo più esattamente, la fraternità francescana, il rapporto tra i frati-fratelli – non è questione di diritto o di «commento alla Regola»: è questione affettiva – sempre nel senso fraterno. Non ci si può soffermare al riguardo, se non permettendoci solo l’affermazione seguente che ha fatto qualcuno, non so se vivo e non so se morto: di non avere mai conosciuto tanta amorevolezza, quanto quella ricevuta da frate da frati.
L’affetto è la sostanza di tutta l’opera poetica che si sta leggendo e gustando – altrimenti non avrei lasciato su carta le precedenti osservazioni vaganti. Ed allora vediamone la natura, ma anche i momenti e le movenze.
L’esigenza di base dell’affettività si colloca in una dimensione umana – e perché non anche cristica, se l’umano è anche di Gesù? – che è quella tenerezza, o diciamo pure semplicemente delicatezza, che nella nomenclatura comune, semplice, quotidiana è detta proprio “umanità” come ad esempio quando si dice di un amico, o di un proprio superiore quale dirigente, o di un nemico: «mi ha trattato (magari non me l’aspettavo da un nemico) con umanità».
«Umanità» è quella della madre nei confronti del proprio bimbo, sia quando gli «dà la poppa», sia quando lo è sgrida con amore; «umanità» è quella di frate Francesco quando, per tramite dei suoi frati, va dai ladroni per servire loro il cibo, pregandoli di accettarlo in nome di Dio; «umanità» è quella della nobil signora dei Settesogli, detta dei Settesoli, quando prepara, a Roma, i mostaccioli al medesimo frate, il quale, per la «umanità» di cui è condito il delicatissimo gesto, li gusta talmente tanto che, a pochissime miglia dalla sepoltura, non si ferma da Chiara e non si fa preparare la sepoltura dai frati ma chiama a sé da Roma lei – indicata da frate Elia «amica» di quel Patriarca che la chiamava fratello –, perché gli porti, alla Porziuncola, i mostaccioli – quelli romani, diversi da quelli napoletani, che sono invece rivestiti di cioccolata – (oltre «un panno di cilicio in cui tu possa avvolgere il mio corpo e la cera per la sepoltura»).
Oh vera grandezza e delicatezza dell’amicizia fraterna!
Condito, ho detto, di umanità il gesto e conditi i dolcetti assaggiati – gli storici fondatamente suppongono che oramai il moribondo non poté se non assaggiarli –, come di umanità conditi erano i frugali pasti – forse una pagnotta di pane nero, un pezzo di cacio e una ciotola di vino – serviti dai frati, in ginocchio – così immagino –, ai ladroni. I quali poi furono pieni di gioia. Tutti: san Francesco, i ladroni, la nobildonna romana. L’«umanità» genera gioia: allora, per restare ancora un po’ in questo convivio frugale ma lieto,
distillerò [“dai tuoi giorni” settembrini]
gocce di gioia
per domani
con il dono
di questo pane condito
con umanità e bellezza
e sfiorato dal sorriso
di angelo moldavo (Gocce di gioia in Parole di luce),
un “sorriso” che torna anche, dopo un “sogno infranto”, ad accendere ancora “speranze” (Caleidoscopio di speranze in Spiragli di luce).
Su questa esigenza di «umanità» si fondano quegli umani rapporti grazie ai quali si esce dal “deserto” che dissecca e si infrange il “muro” della incomunicanza (lessema in L’Vticense aristocratico ouero il Catone di Abate Vincenzo Sgualdi, + 1652). È detto chiaramente a proposito di uno dei tanti “pellegrini” nel mondo, per esprimerci con il poeta, come nei seguenti versi:
La tua notte
è chiara
come il giorno,
Riccardo,
e la tua voce
arriva al cuore.
Tu […]
[…]
abile tessitore
di gioiosi
rapporti umani” (Oltre il buio in Parole di luce).
La relazione dei “rapporti mani” salva dal deserto e rompe il muro dell’indifferenza, abbiamo detto, e riscalda, perché è “gioiosa amicizia” (Anfore vuote in Spiragli di luce). Per cui in
[…] questo buio
che avanza,
unica luce restano i tuoi occhi
a segnare approdi
e indicare speranze.
Nel freddo
che mi stringe
d’indifferenza
il tuo sorriso
riscalda il cuore
nel profondo (Unica luce in Parole di luce).
È sui rapporti di umanità cordiale e sincera – se non è sincera, è l’opposto della «umanità» sopra indicata – che si fonda l’amicizia dalle molte potenzialità benefiche:
Anfora
per la tua sete,
olio
per la tua lampada,
balsamo
per le tue ferite,
profumo d’incenso
per il tuo cuore,
sorriso e lacrima
nel tuo volto
[…] (Amicizia in Parole di luce).
La conseguenza, intrinseca, ineludibile è così alta che tocca il “mistero” creato ed è esprimibile in parole di cui io ho letto assai poche di più focali; sì, perché allora
Cercherò riparo
nel tuo cuore
ostrica perlacea
e tuo sigillo,
rifugio sicuro
in questo deserto
di cenere e luce,
e gli occhi avranno
stupore di sogno,
purificati dal pianto,
[…]
per approdare
su sponde di mistero (Cenere e luce in Parole di luce),
“cercando la luce / del tuo volto” (Come sigillo in Spiragli di luce). Come è nella natura della poesia in quanto tale – rivelazione epifanica di antropiche interiorità –, Giovanni Spagnolo svela i ritmi che cadenzano l’immaginario emotivo, e il modo in cui lo fa onora la dimensione dell’affettività e la letteratura poetica, poiché, “Tu non sai”, sì,
Tu non sai
quante volte
mi sono specchiato
nel mare aperto
dei tuoi grandi
occhi verdi
illuminati
da parole
venute da lontano
ad avvertire
“come l’uom
s’etterna” (Occhi verdi in Parole di luce),
con dichiarato riferimento al Brunetto Latini cui si rivolge Dante. Ma cosa significa, questo? L’amicizia del disinteressato affetto conduce all’elevazione dell’animo.
“Quegli occhi” diventano allora un appuntamento quotidiano che guida i passi e sono come un fulmine e il saluto è “colonna sonora […] alla Purissima” – dantescamente, per la Beatrice – per un “furtivo e fuggente / attimo” (Tra nulla e nulla). E allora:
Aspettarti
ogni giorno
lungo i tuoi passi
[…]
per incrociare
il tuo sguardo
[…]
in un incontro
[…]
tra nulla e nulla (Tra nulla e nulla).
“Attenderti” diventa una cadenza giornaliera come
un mattino
sulla soglia
sperando
epifania di luce
all’apparire
del tuo volto
tra pioggia battente
[…] (Epifania di luce in Parole di luce).
Non meglio si potrebbe tradurre con stile del ventunesimo secolo l’immaginario stilnovistico del tredicesimo toscano, anche perché il nome non conta, al punto che addirittura non lo si conosce (“Non so il tuo nome”, Attimi) e se esiste è perché non sai “di quanta luce / i tuoi occhi grondino / per me / né quanto il cuore / dilatino”
[…] quegli attimi
– tanto attesi –
in cui appari
[…]
[…] e il tuo sorriso
m’avvolge di gioia
colmo di grato stupore
perché le parole
non bastano
a dire l’Amore (Attimi).
Quindi solo “l’attenderti”
è già
indicibile
gioia
che veste
di luce
il mattino (Attenderti in Spiragli di luce).
Uno dei canti lirici di questa tensione è in Certezza di luce di Spiragli di luce, in cui il titolo stesso significa la relazione intrinseca tra l’incontro – la comunicazione – e la sua irradiazione – comprensione profonda – in cui consiste la “luce”. Perciò
Ti attenderò
in silenzio
per captare
lieto rumore
dei passi
che annuncia
il tuo arrivo,
tese allo spasimo
le corde del cuore
in sinfonia di pensieri
pronte all’abbraccio
che colma
ogni vuoto
in certezza di luce.
La lirica raggiunge auliche sfere di vissuti già celebrati da sommi poeti, con un taglio, qui, novecentesco che non disdegna citare “le corde” del cuore e portare in campo lo “spasimo”, in una sfera tra romanticismo e naturalismo, tra idealità e realtà. Ho riportato l’immaginario poetico allo stilnovo dantesco e ho collocato l’aura poetica anche nella cultura novecentesca, perché non si può obliare come i due mondi si possano anche avvicinare, se Canzone di Dalla dagli stupendi versi quali “Io i miei occhi nei tuoi occhi / non li staccherei mai”, pur nel realismo di altri versi, si ispira alla ballata dello stilnovista Cavalcanti nell’inviare la ballata stessa perché vada alla ricerca dello «spirto gentile».
Ed infine l’apogeo della beatitudine, dantescamente: la festa dell’incontro. Anzi no: anche solo dell’attesa! Infatti
Domani
vedrò i tuoi occhi
e già
impazzisce di gioia
il cuore.
E ancora
non so
se mai approdo
ci sarà per me
negli spazi sconfinati
del tuo mare
e del tuo cielo.
Eppure
è festa per me
quest’attesa (Festa).
L’attesa si consuma nell’“incontro”, che si riveste di “luce” e di “pace profonda”: incontro che, sul piano letterario, si può dire dantescamente proiettato nell’“Eterno” e, religiosamente e francescanamente, nel territorio esistenziale della comunione fraterna, la quale concorre al perfezionamento e all’elevazione dell’animo, come s’è già definito con lo scultoreo sintagma dantesco. In ogni caso e sempre, anche un “breve incontro” è “tanto atteso” (Pace profonda in Spiragli di luce).
Non c’è solo l’incontro, a “illuminare” “il gelo” – una “luce / gli occhi tuoi” che dà luce calorosa, illumina e riscalda! – “in questo mare / che minaccia / tempesta” (Giorni incerti in Spiragli di luce). C’è anche l’incontro a distanza: il ricordo. E allora
il tuo sorriso
verrà
da molto lontano
e avrà
radici profonde
[…]
negli abissi
del mistero
[…] (Caleidoscopio di speranze in Spiragli di luce).
Questo ricordo non è solo mnestico, non è tanto un restare nella mente; è un riviversi esistenzialmente (“rimasto nell’anima”, Giugno in Parole di luce), poiché
[…] l’azzurro intenso
di quegli occhi
[…]
è rimasto nell’anima
con l’oro
dei capelli
scolpiti sul volto
dipinto d’infinito (Giugno in Parole di luce).
E dato che qui fanno capolino “i capelli” d’oro di petrarchesca memoria «a l’aura sparsi», mi punge il disio, per echeggiare Dante, accostarli a tutta l’aura della natura nella quale è immersa la poesia in questione, stupendo abbrivio che congiunge naturalità e umanità in quell’“ora / di giugno” in cui
garrule rondini
riprendono a trapuntare
[…]
il cielo limpido
tracciando
ghirigori di speranza
[…].
Enigmatico, in parte, e tranciante, in tutto, il canto del “rimpianto”, sempre a proposito di questa visione universale degli incontri umani, quando, foscolianamente nel “cercare la luce”, noi
Rimpiangeremo
nell’ultimo giorno,
cercando la luce, abbracci mancati
e incontri svaniti,
mani non tese
sorrisi negati
sguardi distratti
e parole non dette
in mattini non vissuti
e tramonti perduti (Cercando la luce in Parole di luce).
Non si può licenziare questa lettura senza riferire i versi di Giovanni Spagnolo su san Francesco d’Assisi. Il primo testo è sull’“angelo crocifisso” (La Verna). Perché il primo aggettivo attribuito a Francesco dal poeta sia “angosciato”, prima ancora che “orante”, non si può capire se non andando alla biografia del Santo e al motivo per cui egli si trovava lì, su quel monte. Certamente per ritirarsi in solitudine orante. Ma per dedicarsi alla contemplazione e al ritiro interiore, che del resto egli praticava molto frequentemente, non c’era bisogno di angosciarsi. Tanto meno ad angosciarsi era incline proprio lui, non solo “giullare” ma anche fidente – per comprendere bene ciò, si deve solo e tassativamente farsi trapassare il cervello dal resoconto delle sue ultime ore di vita e, in esclusiva assoluta, del suo ultimo colloquio con frate Elia, per il quale si consiglia un commento affilato come una spada che trapassa cervello e budella.
Il frate che aveva sognato una cosa tutta nuova, una “forma di vita” semplice e nuova come la Buonanovità, anzi che era proprio quella e solo quella – e che consiste in due cose, anzi in una, se ben si comprende –, vide i suoi seguaci prendere la strada di tutti: la buona strada di tutti i religiosi di quell’epoca e di ogni epoca. Che non era la Buonanovità. Fatto sta che prese con sé tre – dei tre o quattro? O dei quattro o cinque? – che gli erano rimasti più fedeli.
Come poteva non essere angosciato?
Un brivido
percorre
le mie ossa.
Ora capisco:
non era sciroppo
ma sangue:
mistero inaudito e profondo.
Terminiamo questo tratto di strada poetico con “la dolente Madre” che “offre il suo grembo / al Figlio dei dolori”, di Romitello. Ne abbiamo già fatto cenno, ma qui ella ritorna perché, qui – come a me, senza scienza e senza conoscenza, pare d’istinto, – si conclude, come a suo apice, il corpo di testi che inizia con l’“angosciato” alla Verna.
La “dolente” non stava posando a fare la star del cinema. Era addolorata davvero. Per la morte d’un figlio: l’unico. E ammazzato: come tanti. S’è già detto ch’era addolorata per la morte dell’unico figlio. Ma non so se s’è già detto che era “dolente” anche per altro: per sbigottimento. Per il fallimento dell’unico figlio. Non lo diciamo per studio e non abbiamo cultura in materia, lo diciamo per un dato di fatto: un giovane di «belle speranze» – per usare un’espressione vulgata – era arrivato a quel risultato! Non mi interessano le costruzioni da Olimpo degli dei secondo cui la Madre sapeva già tutto – fin dalla annunciazione! –, cioè che il Figlio, certamente uno non da quattro soldi ma uno che era una Persona delle Persone di Dio, stava per risorgere da lì a tre giorni contati alla romana – quindi un giorno e mezzo – e che da lì a quaranta giorni ancora stava per «sedersi alla destra del Padre». Non mi interessano, perché le costruzioni preferisco farle sui testi. Maria, la Madre, si era chiesta che cosa volesse dire quel figlio quando costui se n’era andato per suo conto a Gerusalemme nel tempio, a dodici anni, e che cosa quel figlio facesse mai, quando andarono ad avvertirla che di lui si diceva che «era fuori di sé» – ed ella accorse –, non so se spaventata o al contrario tranquillissima perché sapeva già tutto, cioè che da lì a qualche anno si sarebbe seduto alla destra del Padre. Fatto sta che, se pure non fosse vero che la Madre non era così desolata per il fallimento del figlio abbandonato dagli uomini e da Dio, suo figlio lo era, ed ella lo sentì, ed ella lo capì: ella che gli stava a pochi decimetri di distanza, quando il figlio, inchiodato al palo, non molto alto, gridò ad Elahî (o, in ebraico, Elì),perché mai lo aveva «abbandonato».
Vero è che poi il Figlio, subito, si consegnò al medesimo Eloì, anzi al suo Abba, confermando – si tenga presente: confermando – la consegna di sé già compiuta nell’Orto: una consegna che esattamente ed esclusivamente consiste nel «Sia fatta» – che significa propriamente: «avvenga», sia posta in essere («la tua volontà»). Ma questa consegna di sé è una consegna di sé per quello che di fatto egli è: e di fatto è un fallito. Il fallimento è un presupposto, non solo un antefatto: tanto che, se non fosse stato un fallito, non avrebbe supplicato «nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime […] colui che poteva salvarlo dalla morte» – la morte, appunto, di un fallito (perché non muore mica di morte naturale, ma ammazzato, e ammazzato come «colpevole»!)
Allora si capisce quanto pesi nell’animo e quanto smarrimento generi nel cuore il trovarsi ormai prossimi – “Non è giusto”! (Aprile) – “al capolinea” con il fardello “delle delusioni”, il “capolinea delle delusioni”, “con l’anima lacerata / e il corpo sfinito d’attesa” (Aprile), snocciolando ogni giorno
dolori antichi e nuovi
come grani di melagrana
e, tra sogno e realtà,
[…]
con insistenza chiediamo
perché vivere e per chi” (Domanda).
Allora si capisce perché qui rimembriamo «l’uomo dei dolori», anzi del dolore estremo al Getsemani – cui forse parve essersi mosso in un “inconcludente andare” (Giornata termale) –, se ci sentiamo addosso
Sanguinanti
stimmate invisibili
[…]
e indicibili rimpianti” (Giornata termale).
Non vale stupirsi di un accostamento tra noi, gente che soffre non poco ma che pecca alla grande, e il Cristo innocente che patisce nella sua dolorosa passione: siamo tutti, noi e lui, «nella carne»: se non fosse stato anche lui «nella carne», non avrebbe implorato, «nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime […] colui che poteva salvarlo dalla morte»!
Ma mi piace, proprio per evidenziare come noi umani ci troviamo facilmente e abitualmente percorsi da sentimenti opposti e contrari – salvo i possibili momenti di estremo smarrimento simile a quello dell’Orto di prostrazione –, vedere come il poeta tenga a precisare che le “sanguinanti / stimmate invisibili” non basta a lenirle neppure il “confortante / […] glicine / con la sua ombra” (Giornata termale).
Il poeta è sensibile al conforto della natura, aspira e respira l’azzurro, come frequentemente si legge, percepisce il cadere della neve che tutto copre “di lieve candore” (Nevicata 2010). Ma sa e percepisce anche che la neve cade “su questo quotidiano morire”, sa anche, a sua volta, che «se il chicco di grano non muore non produce il suo frutto»:
e il chicco di grano,
caduto per terra, matura silente
il pane di vita” (Nevicata 2010).
S’è già sottolineato il concetto in altro luogo delle raccolte di Giovanni Spagnolo, ma qui lo riproponiamo per un ulteriore motivo: non basta avere, “impregnati di speranza, / […] certezza / di vita eterna” (Domanda), nonostante ci sia chiesti “perché vivere e per chi” (Domanda). Non basta, perché a un certo punto, al punto estremo dello smarrimento, non resta che un esito – di cui s’è già detto.
Alla fine di questa panoramica di dolore, il dolore di disavventure – “Ancora fughe e ritorni / a tu per tu col Mistero, / nella gioia di lieti mattini, / assonnati meriggi / e stanchi tramonti” (Un’altra estate) –, di attese deluse “tra stupore e speranza” (Naufraghi informatici), di traguardi perduti, di beni svaniti “tra sogno e realtà / […] / dubbi e certezze” (Mattini di rugiada) e disinganni profusi a mani bucate, si sente un brivido, un “brivido / nelle ossa” (Mani antiche di Parole di vita): ritorna quel brivido! Il brivido della Verna! (La Verna). Là, erano forse le parole del silenzio – le parole del crocifisso – a saettare questo brivido di sangue. Qua, sono “mani antiche”, mani “di stirpe profetica” che sembrano “stringersi con forza” e sono
[…] schianto
al cuore
e brivido
nelle ossa
[…].
Allora si invoca
volontà ferrea
e preghiera assidua
ad implorare
finalmente
pace interiore
su rotte di luce.
E allora anche qui torna il «colui che poteva salvarlo dalla morte»!
Si riscontra qui l’impegno, la forza della volontà, la costanza fedele, la perseveranza tenace, indispensabili atteggiamenti per incamminarsi verso la pace su sentieri di luce. Ma l’ammirevole disposizione interiore è sopraffatta da una potenza che non è nostra: che per fortuna non è nostra. È la potenza – anzi no: la presenza – di «colui che poteva salvarlo dalla morte». E che appunto lo salvò dalla morte, proprio grazie alla morte! E allora, adesso, sì, solo allora, cioè adesso, si può supplicare, anzi no, sussurrare – perché è già presente –:
Radicami
nel tuo amore
perché io
trasfiguri in te
limpidi mattini
[…].
E dammi
occhi puri
ad incrociare
sguardi d’azzurro
in profondità sconfinate.
E a questo cuore
sempre in attesa
concedi
luminosi approdi
tra braccia misericordiose
sulle tue sponde (Supplica di Parole di luce).
E non occorre dire: sia così. Perché così già è.
Si potrebbe terminare così, se non ci fosse da menzionare Alla Vergine. Non si può terminare, soprattutto un pezzo di carta che è stato malamente sporcato d’inchiostro, senza chiederci
come facevi
a capire la sua volontà (Alla Vergine di Parole di luce).
“Io non so ancora / […]”. Ma chi è che lo sa! Per capire, c’è un modo soltanto:
Ti offristi in nudità
al Mistero
e hai capito
[…] (Alla Vergine di Parole di luce).
E si capisce, se il Mistero non è misterioso. Si capisce, se il Mistero è manifesto. Ed è manifesto, se è visto. Ed è visto, se
[…] io
resto in silenzio
inabissato nel mistero (Natale di Parole di luce)
e lo si incontra di persona, nello spirito. [Francesco Di Ciaccia]