Forti, Gemma, 2010
Delitto e castigo in miniatura, recensione di Gemma Forti, Ruvido lago, Roma, Fermenti (Nuovi Fermenti. Narrativa), 2010, pagine 163, in Literary.it 12 (2010).
In copertina: opera su carta, Visione (1993) di Franco Verdi
Testo della recensione
La trama di Ruvido lago di Gemma Forti si può inquadrare nel genere del cosiddetto romanzo “giallo”, tanti sono gli ingredienti, consacrati da pluriennale tradizione letteraria, che tendono a definirlo in tal senso. La narrazione stabilisce tuttavia altri punti prospettici, legati alla ricostruzione di alcune tendenze di costume degli anni ’50 del Novecento, localizzati in un immaginario piccolo paese di provincia, nella regione Lazio.
È stato scritto che la narrazione del presente romanzo “definisce una storia nel pieno senso del termine”, una storia della “Italietta degli anni Cinquanta” che focalizza personaggi “di un piccolo mondo davvero piccolo e sufficientemente meschino”[1]. Vi si incontrano individui di umili origini – cui appartiene proprio la protagonista – e individui – soprattutto donne – delle classi più abbienti e di ciascuno sono delineate le peculiarità socio-culturali e caratteriali. In genere, la individuazione è molto accurata, tanto che a volte sembra che il testo si avvicini alla cronaca giornalistica o alla documentazione anagrafica, quando, ad esempio, di alcuni personaggi vengono indicati tutti i connotati con identificazione di nome e cognome dei consorti o delle consorti, degli ascendenti di primo grado o anche dei consanguinei in linea collaterale. Ad ogni modo, i personaggi si stagliano vividamente grazie alle “puntigliose descrizione fisiche”[2] e alle modulazioni psicologiche, che conferiscono alla vicenda immaginaria una atmosfera di notevole spessore realistico.
Di conseguenza, da un piccolo paese di provincia emergono attitudini – potremmo dire vizi e virtù – di cui alcune rientrano in un quadro sociologico consolidato e datato – per l’appunto, all’epoca in cui è collocata la storia del romanzo, forse con una venatura di nostalgia, come è stato avvertito[3] -, quali la sottomissione delle ragazze ai voleri genitoriali, la viscida libidinosità di maschi di bassa estrazione sociale o l’attitudine dongiovannesca dei giovani dell’alta borghesia romana, mentre altre, che potrebbero sembrare insospettabili, appaiono più generalizzabili, come la tendenza lesbica di signore “bene”, la stridula altizzosità di chi si sente importante – ed ama farsi ritenere più importante ancora – e gli oziosi, morbosi e pestiferi pettegolezzi di chi non ha niente da fare se non di impicciarsi degli affari altrui: connotazioni anche queste, tuttavia, che dipingono bene alcune stratificazioni mentali e comportamentali di un’Italia – e non solo – arcaica e culturalmente miserevole.
Di Ruvido lago è stato anche affermato che potrebbe essere inteso come “romanzo di formazione”, in riferimento all’evoluzione psicologica di una giovane, Caterina, che da ignorante e sottomessa si evolve, anche grazie all’amore sentimentale e passionale, fino a diventare volitiva e sicura di sé. Se si può pur dire che il personaggio è “ben delineato a livello psicologico”[4], tuttavia si deve anche avvertire che la narrazione non segue l’andamento della evoluzione psicologica: lo sviluppo della personalità appare un risultato, non una dinamica in progresso, anche perché nella passione della ragazza per il giovane d’alta classe fa sorgere il sospetto che si annidi un bisogno di rivalsa rispetto alla condizione sociale di subalternità – come di fatto poteva spesso accadere, all’epoca in questione.
Più propriamente, come ho accennato all’inizio, il romanzo sembra costituire un “giallo”: la storia di violenza da parte di un uomo che, in un primo momento, uccide una ragazza – abbandonata poi nel lago –, perché rifiutato rispetto a un approccio erotico fondamentalmente estemporaneo (per quanto fondato su un reale bisogno d’affetto e di tenerezza umana), e che, in seguito, progetta di ucciderne un’altra, della quale si era innamorato da tempo ma che non aveva mai osato corteggiare, perché intimorito dal carattere riservato e timido di lei – la suddetta Caterina, appunto, inizialmente fragile e pudica -, finché, spiandola, egli ebbe a vederla tra le braccia di un bel giovane seduttore.
La narrazione illustra la personalità dell’omicida, grazie all’ausilio della criminologia – di cui oggi sono gravide le cronache sugli assassini – e disvela una dinamica aberrante – di cui, di nuovo, sono pieni i resoconti televisivi e gli articoli della carta stampata. Si tratta proprio di un maniaco: il quale poi si fa incastrare facilmente dagli inquirenti, esattamente come spesso avviene a individui così gravemente disturbati a livello psichico e mentale, e infine, sfuggito alla sorveglianza degli agenti, altrettanto facilmente si spinge con una barca in mezzo al lago e si uccide barbaramente – un suicidio, come castigo, perfettamente congruo, per efferatezza, al delitto commesso.
Alla fine, dopo una vicenda collocata con puntualità temporale – il tutto si conclude il 6 ottobre 1955 -, la protagonista, suddetta Caterina, divenuta adulta rimette in dubbio tutto il vissuto precedente: non sapeva più se quanto ricordava del passato, “che appariva con tanta pregnante evidenza alla sua memoria vacillante, era vero o frutto della sua fantasia” (p. 155). Lo stratagemma della fluidità e inaffidabilità mnestica, affidato alla coscientizzazione della protagonista, forse serve all’autrice per enunciare il principio che governa ogni invenzione romanzesca: tutti gli elementi diegetici potrebbero essere differenti. Caterina sarebbe potuta essere, ad esempio, una aspirante velina ed essere, magari, “una Luisa, una Marisa, una Giovanna, una Patrizia, o chicchessia” (p. 155); i commercianti sarebbero potuti essere negozianti tartassati dall’usura e dalla mafia; le varie signore dell’annoiata borghesia paesana sarebbero potute essere altrettante signore urbanizzate, addirittura frequentatrici dei siti Internet, e così via, personaggio per personaggio, ipotizzato in professioni differenti e con virtù e vizi tipici di periodi storici più propinqui ai nostri tempi e in contesti geografici differenti. Questo ribaltamento prospettico sembra sia stato molto apprezzato dai critici, compreso Giorgio Bàrberi Squarotti. In pratica, per fare un solo esempio, noi verremmo a scoprire, raccogliendo una tal rivelazione di teoresi letteraria, che la Lucia manzoniana sarebbe potuta essere una lavandaia del primo ventennio della Milano ottocentesca – una Lucia magari più disinvolta, anzi appassionata di valzer in gaia compagnia, non esclusa quella di Abbondio, il quale sarebbe potuto essere, segreto amante, un affiliato della Carboneria -; Renzo, suo fidanzato, sarebbe potuto essere un prestinaio – magari al “Forno delle grucce”, in via Corsia dei Servi, in quel di Milano -; Agnese sarebbe potuta essere una domestica di casa Serbelloni, dove non molto tempo prima aveva svolto il compito di istruttore l’abate Giuseppe Parini; Federico Borromeo sarebbe potuto essere Carlo Gaetano Gaisruck, cardinale arcivescovo di Milano dal 1818 al 1846, e così via, ovviamente ciascuno con chissà quale altro nome. Lucia, per esempio, sarebbe potuta essere Rosaria – magari perché, la sera, ci teneva a recitare il santo rosario con il fidanzato Renzo, che a questo punto si sarebbe potuto, però, chiamare Lucio, e di cognome Cassoeula, in onore di Milano, invece dell’insignificante Tramaglino.
Per il vero, questo problema teorico, che ho sollevato io in questa lettura del romanzo, non può essere risolto nel modo qui da me stesso ipotizzato, se si accetta la concezione, che fu di Pirandello, secondo cui la “storia” d’invenzione – “storia” con tutto il suo contenuto di personaggi in un contesto di luogo, tempo e spazio – s’impone con un dinamismo di “necessità” alla mente dell’autore, una volta che nella mente stessa la storia è nata e si è imposta – al punto che egli non può intervenire, neppure volendolo, mentre, di contro, sono i personaggi a imporsi sul suo processo ideativo. L’autore è pur libero di cambiare una “storia”: ma, una volta che gli balena un’altra storia, questa storia è appunto altra.
Tuttavia, nel caso di Ruvido lago si afferma direttamente ed espressamente soltanto un processo: la protagonista perde la memoria del suo passato, tranne l’epilogo della vicenda nella quale ella era stata implicata.
[1] Antòn Pasterius, Un “Ruvido lago” di Gemma Forti, traduzione di Antonino Lo Cascio, in www.Fermenti-editrice.it/schede/Recensione_Pasterius_Ruvidolago.pdf.
[2] Donato di Stasi, La littérateuse en abîme. Piccolo vademecum per percorrere il Ruvido lago di Gemma Forti (Fermenti 2010), in www.Fermenti-editrice.it/schede/Recensione_Di%20Stasi_Ruvido_Lago.pdf.
[3] Donato di Stasi, loc. cit.
[4] Raffaele Piazza, Nota a Ruvido lago, di Gemma Forti, in www.poien.it/autori/2010/2010_07/03_Piazza_Forti.htm.

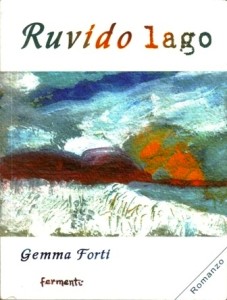
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.