Annali Manzoniani, 1990
Elenco delle recensioni unitarie, nell’ordine del testo in Rivista, nel volume Annali Manzoniani, Nuova Serie, I, 1990.
Manzoni: il suo e il nostro tempo. Poesia politica religione nel decennio 1812-1822. Atti del Congresso Nazionale di Studi Manzoniani. Busto Arsizio 16-17-18 novembre 1984, a cura di Umberto Colombo, Comune di Busto Arsizio – Centro Nazionale Studi Manzoniani, 1987, pagine XV-224, «Annali Manzoniani», I (1990) pagine 254-257.
Manzoni e Brusuglio. Atti del Convegno su Enrichetta Blondel e del Congresso Nazionale sul pensiero politico-sociale di Alessandro Manzoni, tenutosi a Cormano nel bicentenario della nascita dello scrittore, in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Manzoniani, Comune di Cormano, 1986, pagine 129, «Annali Manzoniani», I (1990) pagine 257-259.
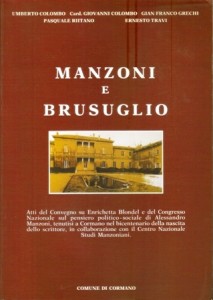 In copertina: Villa Manzoni, Serigrafia di Giuseppe Milanesi
In copertina: Villa Manzoni, Serigrafia di Giuseppe Milanesi
Manzoni. Il suo e il nostro tempo. Politica ed economia in Alessandro Manzoni. Atti del Convegno 22-24 febbraio 1985 Bergamo, Comune di Bergamo – Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo – Centro Nazionale Studi Manzoniani, 1985, pagine 152, «Annali Manzoniani», I (1990) pagine 259-261.
Attualità della «Storia della Colonna Infame». Atti Congresso Manzoniano. 15-16 giugno 1985 Boario Terme, Azienda Autonoma di Cura e Soggiorno – Comune di Darfo e Boario Terme – Centro Nazionale Studi Manzoniani, Azzate, Edizioni «Otto/Novecento», 1987, pagine 133, «Annali Manzoniani», I (1990) pagine 261-262.
Manzoni e il suo impegno civile. Manifestazioni Manzoniane a Brescia, 4-6 ottobre 1985, Centro Nazionale Studi Manzoniani – Università Cattolica del Sacro Cuore – Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Brescia – Comune di Brescia, Azzate, Edizioni «Otto/Novecento», 1986, pp. 341.
«Fermo e Lucia». Il primo romanzo del Manzoni. Atti XIII Congresso Nazionale Studi Manzoniani. Lecco, 11-15 settembre 1985, a c. di Umberto Colombo, Centro Nazionale Studi Manzoniani – Comune di Lecco, Azzate, Edizioni «Otto/Novecento», 1986, pagine 237, «Annali Manzoniani», I (1990) pagine 265-270.
Letture Manzoniane 1987, Casa del Manzoni – Centro Nazionale Studi Manzoniani, Azzate, Edizioni «Otto/ Novecento», 1988, pagine 103, «Annali Manzoniani», I (1990) pagine 270-272.
Alessandro Manzoni, La prima stesura inedita della «Lettre a M. Chauvet», a c. di Aldo Rosellini e Umberto Colombo, prefazione di Guido Bezzola, Casa del Manzoni – Centro Nazionale Studi Manzoniani, Azzate, Edizioni «Otto/Novecento», 1988, pagine 139, «Annali Manzoniani», I (1990) pagine 272-273.
Testo delle recensioni
In occasione del bicentenario della nascita del Manzoni, il CNSM ha organizzato una serie di Convegni e Congressi nel quadro di un evidente interesse non già circoscritto alla «scrittura» del Lombardo, ma allargato alle sue «idee». L’avvio è stato perciò dato dal Congresso Nazionale su «Poesia, politica, religione nel decennio 1812-1822» (Busto Arsizio, 16-18 novembre 1984). A sottolineare la personalità umana del Manzoni, un Convegno ha posto l’attenzione sulla «diletta e venerata» Enrichetta Blondel (Cormano, villa di Brusuglio, 22 dicembre 1984). Poi il tema ideologico e civile è stato ripreso nel Convegno di Bergamo (22-24 febbraio 1985) su «Politica ed economia in Alessandro Manzoni» e continuato con costanza: Congresso Nazionale di Cormano (villa di Brusuglio, 12-14 aprile 1985) su «Pensiero politico-sociale di Alessandro Manzoni»; Congresso di Boario Terme (15-16 giugno 1985) per l’«Attualità della Storia della Colonna Infame»; Manifestazioni bresciane (4-6 ottobre 1985) su «Manzoni e il suo impegno civile».
Un Manzoni «vivo», dunque, criticamente rivisitato e prudentemente attualizzato: poiché egli non è soltanto un «grammatico», come ha bene osservato Giancarlo Vigorelli, ma è anche un pensatore che fa riflettere sull’«oggi», come sul suo tempo egli ha riflettuto ripercorrendo l’umanità di «ieri» e di sempre, inesaustivamente «raddrizzabile» con la ragione e con la «pentecoste».
Il CNSM non ha obliato il Manzoni letterato, non solo studiandone l’«eterno lavoro» linguistico, ma anche rilanciandone quel grande «abbozzo» del romanzo che è il Fermo e Lucia, a cui si intitola il XIII Congresso Nazionale Studi Manzoniani (Lecco, 11-15 settembre 1985).
Infine, il CNSM ha trovato nuova linfa per riprendere, sotto la guida di Giancarlo Vigorelli, le «Letture Manzoniane», sospese nel 1981.
Il primo Congresso, Poesia politica religione nel decennio 1812-1822, si è svolto nella patria di Luigi Tosi, a cui dedicano un’attenzione partecipe il card. Giovanni Colombo, con I tre vescovi del Manzoni (pp. 219-224) – cioè i due Borromeo e il Tosi -, e Paolo Magnani, con La figura pastorale di Luigi Tosi e l’ideale di vescovo secondo Manzoni (pp. 3-15), il quale nell’immagine di Federigo vede riflessi i caratteri preminenti della spiritualità del Tosi.
Gli interventi sulla poesia manzoniana iniziano con l’originalissimo apporto di Paolo Bosisio, «II Conte di Carmagnola» e la tecnica teatrale del Manzoni (pp. 19-55). La vecchia diatriba sulla rappresentabilità teatrale delle tragedie manzoniane trova una risposta positiva, se ci si richiama estrinsecamente alla Lettre e agli scritti dei Materiali estetici e, intrinsecamente, alle didascalie «scenografiche» e «registiche» delle tragedie. Ad onta delle opposte dichiarazioni del Manzoni circa la loro teatrabilità, non va dimenticato quanto egli fosse consapevole della novità drammaturgica in un panorama italiano ancora estraneo alla rivoluzione preromantica e romantica europea, prevedendo l’ostracismo dei critici e l’incomprensione del pubblico. Pubblico, sì: e Bosisio passa diligentemente in rassegna le produzioni teatrali delle due tragedie, indagando con precisione sulle Compagnie, sui capocomici e sugli attori. La disamina occupa una serie di note estremamente interessanti per gli studiosi del teatro. Quanto agli aspetti concettuali della drammaturgia manzoniana, essi rientrano fra i noti perni della sua poetica, di cui richiamo solo quelli relativi alla tecnica dell’intervento: linearità logica che rifugge dall’uso dei «colpi di scena», ribellione alle unità, eliminazione dell’antefatto a favore dell’azione drammatica, intesa non solo come «peripezia», pretesa da Chauvet, ma anche come itinerario psicologico; e le narrazioni acquistano anch’esse il carattere di «rappresentazione narrata». Una meticolosa analisi tecnica del Carmagnola ne dimostra la piena teatrabilità. Ad esempio, le didascalie passano da 43 a 55 (nell’Adelchi, da 55 a 92) tra la prima stesura, la seconda (parziale) e l’opera a stampa; il dialogo, grazie all’eliminazione del confidente che favoriva il monologo incrociato o criptomonologo, si presenta prevalentemente come tale; il monologo rientra shakespearianamente nello schema dell’«azione psicologica»; nell’uso delle scene, definite non più in base all’entry o all’exit dei personaggi ma ad un progetto di struttura drammatica, sono eliminate le scene di passaggio, intrinsecamente destinate a salvare l’unità e quindi programmaticamente superflue per Manzoni; e comunque anche le entrate e le uscite sono drasticamente ridotte al minimo.
Al lettore di questo pazientissimo saggio vien da fare una considerazione sul fatto che Manzoni usa, come nel linguaggio, la stessa «parsimonia» retorica nelle scene ad effetto per l’applauso: se ciò poté alienare la simpatia degli attori ottocenteschi, dovrebbe invece costituire un sorprendente elemento di modernità nel contesto delle odierne linee teatrali.
Antonia Mazza Tonucci, Le «Osservazioni sulla morale cattolica» e «I Promessi Sposi»: dall’apologetica alla poesia (pp. 115-128), esamina il valore anticipatorio delle Osservazioni rispetto alle concezioni e addirittura alle immagini concretatesi in «poesia» nel romanzo, dopo aver sgombrato il campo dai fraintendimenti che dipingono un Manzoni «succube» del Tosi nell’affrontare la critica al Sismondi. Oltre ai singoli riscontri, molto illuminanti, l’idea di fondo – un filo rosso del romanzo, come pure dell’Adelchi – che la religione ha una benefica ed essenziale funzione nel privato e nel pubblico, è tutta contenuta nel libro apologetico. E allora come mai l’Autore ha impiegato tanto tempo a redigere le Osservazioni, facendo trepidare un po’ Luigi Tosi? La studiosa mette il dito su un grande problema: la progettazione linguistica. Manzoni non andava a spanna, al riguardo. E se in Francia la prosa apologetica possedeva una configurazione consolidata, in Italia che cosa c’era, nel primo ventennio dell’800? Allora s’impazientisca pure, il Tosi! Altro che succube, quel cocciutissimo Alessandro.
Con Luigi Santucci, Un romanziere rilegge la peste nei «Promessi Sposi» (pp. 131-139), la parola a un letterato: il quale con fine sensibilità rivede volti sfigurati e vinti, volti trasfigurati per potenza d’amore e di carità, mentre c’è chi muore in bellezza su un letto di… stelle e chi, con gli arti spezzati, sui carri. Ci son per tutti, i colori di morte: ma non senza una metafisica che vede al di là dell’ingranaggio pestifero.
Sempre sulla peste, con scoperte di probabili fonti manzoniane, sono gli interventi di Ennio Sandal, Una poco nota fonte del Manzoni: la «Historia universale» di Gaspare Bugatti (pp. 143-149), e Franco Bertolli, Un manoscritto bustese tra le fonti del Manzoni? (pp. 153-167). I nessi testuali tra la narrazione manzoniana e I fatti di Milano, al contrasto della peste, over pestifero contagio, un testo edito nel 1578 e poi confluito in L’aggiunta dell’Historia universale del medesimo autore domenicano, «Gasparo Bugati», fanno ritenere che il Manzoni lo abbia letto. Anche perché il romanziere cita lo scrittore cinquecentesco a proposito dell’etimologia del termine «monatto» e lo menziona tra i libri di don Ferrante; anzi, nel Fermo e Lucia ne ricorda proprio la «storia universale».
Coincidenze e riscontri fanno ritenere possibile, come ulteriore fonte manzoniana, un anonimo manoscritto del 1632, Storia della peste avvenuta nel borgo di Busto Arsizio. 1630. Le connessioni si rilevano fin dall’esordio del cronista e sono, poi, così stringenti, che anche Umberto Colombo è convinto del debito manzoniano nei confronti di questo scritto, la cui paternità è da attribuire al canonico Giovan Battista Lupi (pp. 159-164). Manzoni può aver consultato il manoscritto presso i Belgioioso, cui esso appartenne nell’800.
Tra etica e poetica Umberto Colombo, I silenzi del Manzoni (pp. 175-216), riflette su autocensure del Manzoni intorno ad aspetti e momenti della sua vita. Ma se i silenzi «biografici» sono facilmente spiegabili, problematico appare invece il «lungo silenzio» letterario e politico, dal 1840 – più esattamente che dal 1827 – al 1850. Immediatamente rilevato dai contemporanei e variamente interpretato – il critico, come sempre, è esaustivo e preciso, nella documentazione -, ora deve essere giudicato in modo capovolto rispetto all’assioma desanctisiano, secondo cui «il critico impose silenzio all’artista». Al contrario, infatti, «il critico venne in aiuto al poeta» (p. 202). E come? Scoprendo la «metafisica della poetica», Manzoni, tutt’altro che muto, in quegli anni parlò a fondo: dentro di sé. E, superando i lunghi e tormentosi assilli sul significato dell’arte – anche questi, ripercorsi puntualmente dal Colombo -, scoprì che anche il Bello è garantito: in Dio, nel quale esso è, esattamente come il Verbo ed il Bene. È il vertice ideologico, per un poeta: salvare la poesia, giustificandola pienamente.
Su un grave giudizio del Manzoni interviene Aurelia Accame Bobbio, Alessandro Manzoni e la «pace orribile» della Restaurazione (pp. 57-84), un giudizio già insito nel Proclama di Rimini e approfondito nella «meditazione sul male storico dalla quale matureranno le tragedie» (p. 61): la «pace» che realizza l’offesa, nella Restaurazione del 1815 come al tempo del conte di Carmagnola. In ogni caso, la pace imposta con la forza, che neppure ammetta il confronto ideologico o la difesa personale, è nefasta: per cui il Manzoni sostiene le libertà democratiche, distinguendole, a differenza dei reazionari, dai fondamenti laicistici e riconsegnandole al Vangelo. Neppure l’equità sociale va conseguita mediante la dittatura dei governi o l’imposizione delle piazze coi relativi dispotismi, ma con «lenti sforzi della giustizia» (cfr. il Discorso sui Longobardi) e l’accoglimento degli insegnamenti evangelici. Intendiamoci: la religione non è un «sistema sociale» (cfr. le Osservazioni del 1819), è ispiratrice di cambiamenti verso una maggiore giustizia. Però nessun sistema, né capitalistico né socialista, può credersi sulla retta via, finché al principio della giustizia sostituisca il principio dell’utilitarismo.
Come ognuno può notare, in questi studi non si fa accademismo, né si ozia: di questioni fondamentali, si va trattando. Senza perdere mai di vista, con lucidità e aderenza ai testi, il Manzoni: il quale – lo dimostra ampiamente Accame Bobbio – è stato sempre dalla parte dell’umanità afflitta, contro ogni tentativo di affliggere l’umanità, nel privato quanto nel pubblico.
Sul versante religioso-poetico si colloca Ernesto Travi, I tre tempi della «suite» degli Inni sacri (pp. 87-112). La «raccolta» degli Inni – «suite», nell’espressione manzoniana al Fauriel, 9 febbraio 1814 – ha operato una profonda trasformazione metrica rispetto alle soluzioni tradizionali, per «calare» la teologia nella vita, decisamente sempre più allargata e radicale. Dopo la Resurrezione, la cui riflessione religiosa è occasionata da un evento di «famiglia», nasce lo specifico progetto di poesia «sacra», da una dimensione esistenzialmente più «totale» – Il nome di Maria e II Natale – a quella storica – La Passione, congiunta ai coevi componimenti politici -, fino, con La Pentecoste, alla teologia della grazia universale: un’acquisizione che si è andata intanto rassodando dal Carmagnola al Cinque Maggio.
Questo è l’apporto, in sintesi ridottissima, dell’attento critico: ma la sua disamina si articola in una varietà di solide e chiare osservazioni su molteplici aspetti, linguistici, cronologici e interpretativi, degli Inni, tanto da costituire un importante saggio al riguardo.
Manzoni e Brusuglio raccoglie gli interventi al Convegno su Enrichetta Blondel e al Congresso sul Pensiero politico-sociale di Alessandro Manzoni. Umberto Colombo (pp. 13-14) vi affronta il «mistero» di Enrichetta. Mistero: perché? Per il «silenzio» del Manzoni e per la grande unità d’amore. Ma se il poeta tacque sulla moglie, lo fece non solo per una poetica dell’oggettivazione – per cui le esperienze esistenziali son trasferite nei personaggi -, ma anche per la sua presenza ispirativa, che si diffondeva, «nascosta» nel segreto dell’impulso creativo, in tutte le «invenzioni» che facevan capo a lei, donna «domestica», donna di «bontà», donna d’«umiltà», donna di «pietà»: attitudini e doti di Enrichetta – il Colombo lo documenta – e qualità dei personaggi positivi del romanzo. E quale l’origine di tanto amore ispirativo? Il momento cruciale si pone quando Alessandro sottrasse a lei, dolce, forte e credente, la primogenita. Il drammatico disorientamento della donna, che si trovò «un marito diverso» (p. 17), dovette essere un sacrificio che generò innamoramento: più profondo, in Manzoni, di quello iniziale.
Onde si capisce perché Enrichetta fu «musa»: tanto che – testimoniò il poeta e lo ricorda in un breve intervento Giovanni Colombo (p. 45) -, «ora che è morta Enrichetta, è la poesia che viene a cercare me e non mi trova». Forzatamente così ridotta, la mia esposizione non riflette quel che è di fatto il saggio di Umberto Colombo: il primo abbozzo di una biografia sulla moglie del Manzoni.
Sugli aspetti politico-sociali al Congresso di Cormano, invece, introducono il discorso Pasquale Riitano, II problema sociale nel Manzoni (pp. 47-53), con una premessa sul contrasto città-campagna nell’opera manzoniana, e Gian Franco Grechi, Denunce di crisi dei poteri in alcune opere del Manzoni (pp. 55-67). Il Grechi individua gli elementi del discorso manzoniano sulla politica, scandito con allargamento di orizzonti dal romanzo alla Colonna Infame al saggio sulla Rivoluzione francese. L’importanza interpretativa del Grechi, noto per il suo impegno nel far conoscere l’ultimo scritto manzoniano, è nella conclusione secondo cui il Lombardo non denuncia la rivoluzione in quanto tale, ma nel suo uso arbitrario, che ad altro esito non perviene, di conseguenza, se non a quello di nuocere, quando l’aspirazione al giusto diritto sia fondata su un arbitrio di diritto, come una «autoproclamazione» giuridicamente infondata.
Il discorso politico si incrocia inevitabilmente con quello religioso, nel Manzoni, sia perché la Chiesa rivestiva, all’epoca, un potere temporale, sia perché i fondamenti della moralità collettiva si radicano, per lui, sui valori evangelici tramandati dalla Chiesa. E qui si entra subito nel nodo del dramma manzoniano, analizzato da Umberto Colombo, Potere politico e potere religioso in Manzoni (pp. 69-101). Circa il primo punto, il Manzoni fu pubblicamente favorevole al superamento del potere temporale del Papato, e non solo come corollario dell’Unificazione, ma anche come possibilità di accrescimento dell’incidenza morale e come avvicinamento «ai precetti del suo Divin Fondatore» (testimonianza di Vittoria Manzoni). La speranza illuminata – e fu profetica! – era che, preparata dalla provvidenza attraverso il processo storico, la rinuncia allo Stato Pontificio avvenisse con l’«assentimento dello stesso Pontefice»: non Pio IX, ma un altro, come il Manzoni scrisse al Rosmini. A parte le prospettazioni sulla soluzione pratica dello «spazio vitale» da assegnare al Papato, fondamentale è la teoria manzoniana sui rapporti tra potere politico e potere religioso: i «dogmi politici» sono subordinati alla suprema regola morale proposta dalla dottrina cristiana, ma non in «senso organico» o «istituzionale» – così si esprime Giuseppe Belotti -, poiché la religione è «stimolo», senza coazione statuale, di giustizia e d’onestà.
Ernesto Travi, La lirica civile del Manzoni (pp. 103-122), dopo aver documentato la tendenza antiaristocratica del Manzoni fin da giovanetto, poi realizzatasi in una poesia antitirannica ben più radicale di quella del Parini, e dopo aver avvertito che la precipua contestazione manzoniana è sul versante sociale con la scelta poetica della «plebe» (primo Sermone) e poi degli «umili», svela acutamente una cosa importantissima: è la direzione construens, propositiva, a guidare l’Autore dall’«insoddisfacente ironia» del ghigno sardonico (p. 112) alla poesia di aspra ma positiva bellezza (A Partenide). Iniziando, in parte, con In morte di Carlo Imbonati e continuando con l’impegno civile di Le visioni poetiche, Manzoni perviene alla Resurrezione, in cui la società è vista nel suo nucleo originario, la famiglia, e in rapporto al suo modello ideale, la comunità dei credenti. La Passione, poi, proclama – in occasione dell’ammazzamento del ministro Prina – che offendere una creatura umana è errore originale ed è disgrazia per la civiltà terrena. E così rinasce il canto del coinvolgimento politico per la patria dilaniata (Aprile 1814) e, legati da una prospettiva di partecipazione civile e morale di tutto il popolo al bene comune, si snodano in pochi anni II proclama di Rimini, il Carmagnola, L’Adelchi, Marzo 1821. «E fu una sempre esplicita denuncia in nome di uno sviscerato amore per il popolo» (pp. 121-122) anche il «secondo amore» del Manzoni: la ricerca di una lingua unitaria.
Gli Atti del Convegno di Bergamo, Politica ed economia in Alessandro Manzoni, iniziano con la prolusione «attualizzante» di Umberto Colombo, Manzoni oggi (pp. 15-28), tesa sia a rettificare l’erronea immagine d’un Manzoni «conformista», sia ad evidenziarne gli incentivi fecondi per un ripensamento della società, della storia, dell’uomo. Se il Manzoni fu un «ribelle» incorreggibile, fu anche un «savio» – per esprimermi con l’antinomia di Ugo Dotti -; ed ha capito a fondo che la storia non è un processo astratto di forze autonome: è la dialettica di singole personalità oggettivamente strutturate, ciascuna delle quali, migliorandosi, «coopera alla riforma dell’intero corpo» (p. 23). Insieme, certo: ma in modo che i «tutti» non siano una «massa amorfa» irrazionale e devastatrice, ma una pluralità di spiriti pensanti «con la propria testa». Manzoni non insegna questo? Certo, lo insegna: basta studiarlo «per intero». È il costante invito di Umberto Colombo.
Enzo Noè Girardi, Manzoni: ideologie e ispirazione (pp. 29-34), con la sua abituale rigorosità logica ed espositiva fa il punto, chiaro e difficilmente contestabile, sui rapporti tra ideologia e poesia nel Manzoni e poi sul pensiero economico-politico. La questione sorge dal fatto che il romanziere ha eliminato nelle stesure definitive la riflessione sui provvedimenti di politica economica da adottare durante la carestia. L’espunzione non va attribuita alla presunta incompatibilità tra ideologia e arte e infatti anche nella stesura emendata l’ideologia liberista balza evidente nell’ironia sull’operato di Ferrer -, ma alla misura di compenetrazione dell’ideologia nella poesia. La digressione sull’economia, nel Fermo e Lucia, aveva il carattere di scrittura logico-pratica, disquisitiva, «saggistica» s’è detto altrove -, estraniata dalla «scrittura poetica». La medesima correzione di fondo avviene per quella particolare «ideologia» che è la teologia cattolica: mentre nei primi Inni sacri il riferimento teologico è agli elementi visibili e istituzionali della Chiesa, perciò ancorato ad una «teologia della parzialità» – come il critico la definisce -, nella Pentecoste l’impulso ispirativo procede dal trascendente come «segno» di speranza per tutti, quindi deriva da una «teologia d’ispirazione», in altri termini da una teologia dell’«universalità». Così Girardi supera sia l’alternativa laica tra teologia e poesia, sia la confusione tra l’una e l’altra. Nella più matura ispirazione poetico-religiosa del Manzoni, il sacro è «dislocato»: per nulla «svuotato»; è, anzi, diffuso «per tutto» – è parola di Lucia -, ovunque ci sia carità verace, di Dio e dei fratelli.
Tutto il discorso si raccoglie, conseguentemente, in un principio basilare, che vale per l’economia come per ogni altro specifico settore dell’attività umana: il cristianesimo non è, nel Manzoni, un «sistema» di pensiero filosofico, ma un «sistema estetico, quindi analogico: ove eternità e storia, opera di Dio e opera dell’uomo, attività spirituale e attività economica non sono nozioni alternative ma concomitanti, non implicano ordini contrapposti, ma paralleli» (p. 43).
Nel documentato ed estensivo suo studio, Giorgio Bàrberi Squarotti, Bergamo e Venezia nell’opera manzoniana (pp. 45-68), sempre pronto a disincantare, come ha fatto il Manzoni, l’uomo contemporaneo dalle euforie storicistiche, offre le coordinate tecniche dell’ordinamento politico-economico nella Repubblica Veneziana, per far comprendere il Fermo e Lucia: là non manca la «possibilità di progresso e di incremento della ricchezza attraverso la collaborazione fra il capitale e il lavoro» (p. 47). Poi la seconda stesura ridimensiona questa «cuccagna». Perché? Forse perché il romanziere non crede più, tanto, al vantaggio di una economia «moderna», borghese e liberista? No: ci crede ancora. Ma attento, sembra dire a Renzo: non credere che, allora, sia «già il paradiso» (p. 56). Ed è la pura verità.
Addentrandosi nello specifico dell’aspetto politico-economico del romanzo, analizzato con scrupolosità, Simonetta Bartolozzi Batignani, Teoria e politica economica nel «Fermo e Lucia» e ne «I Promessi Sposi» (pp. 69-94), deduce che la «ricetta» manzoniana di aumentare la paga degli operai in tempo di carestia sottende l’idea di «partecipazionismo», dato che, nel presupposto di una recessione economica, è assurdo elevare i salari per «logica di mercato». Altrettanto, nella proposta manzoniana di creare nuovi posti di lavoro – suffragata del resto da Melchiorre Gioia – sarebbe forse suggerito il compito dello Stato di farsi carico dei disoccupati e dei meno abbienti. Ma perché ne I Promessi Sposi queste due misure economiche scompaiono, e resta soltanto quella del libero mercato – e quindi del libero prezzo – (oltre alla «elemosina»)? Le risposte avanzate son due. Una è tecnica: un salario elevato comprometterebbe ancor di più la già scarsa disponibilità dei beni sul mercato e aggraverebbe la possibilità d’acquisto da parte dei disoccupati. L’altra è generale: il modello economico manzoniano sarebbe quello «di un sistema produttivo in cui sia garantito a tutti un minimo vitale che può ottenersi, in conclusione, soltanto affidandosi alla saggezza provvidenziale delle leggi di mercato» (p. 87). Tutto sommato, quindi, la cultura economica del Manzoni è ancorata a quella «annonaria della fine del ‘700» (p. 92).
Una dettagliata esposizione dell’economia bergamasca in tempi calamitosi è svolta da Giuseppe Belotti, Effetti della peste del 1630 nell’economia di Bergamo (pp. 95-112): da esperto di cose patrie e manzoniano qual è, il senatore Belotti offre ragguagli utilissimi per comprendere anche I Promessi Sposi, nel cui cap. XXXIII l’Autore rimanda all’opera di Lorenzo Ghirardelli per la peste bergamasca. E lo studioso qui la illustra e commenta.
Inoltre Giuseppe Belotti, contraddicendo argomentatamente i pareri contrari, identifica l’Innominato in Bernardino Visconti: Francesco Bernardino Visconti era o non era l’Innominato manzoniano? (pp. 145-152).
Daniele Rota, L’eredità delle opere letterarie ed altre notizie manzoniane in alcuni inediti dì Giovanni Sforza (pp. 113-143), tra l’altro pubblica 21 missive inedite, che comprovano le successive proprietà degli scritti manzoniani: da Pietro Manzoni ai propri figli, poi da Pietro Brambilla, marito di Vittoria Manzoni, al proprio fratello Giovanni, il quale conferma l’incarico a Giovanni Sforza di curare l’edizione, definitivamente affidata all’editore Hoepli.
Attualità della «Storia della Colonna Infame» costituisce il rilancio d’un testo tanto accantonato quanto importante, comunque inquietante e scomodo, perché non tace sulla responsabilità individuale pur nella forza dei costumi di un’epoca. Lo sottolinea Giancarlo Vigorelli, La «Colonna Infame» in primo piano (pp. 67-75), in un panorama ragionato delle edizioni del libro, poi rilevando il timbro lombardo dell’ostinata esperienza di Manzoni e di Mino Martinazzoli (Martinazzoli e la «provocazione manzoniana», pp. 125-131), il quale, con garbata spigliatezza colloquiale, focalizza l’essenziale della valutazione etico-giuridica manzoniana: quando, in un processo, si vuol ottenere ciò che fa comodo, le norme non bastano a garantire l’equità (La «Colonna Infame» tra la pietà e l’ironia, pp. 11-23). In sostanza, si tratta dell’eterno problema del bene e del male nella storia: le circostanze dei tempi, ovviamente ineludibili e certamente condizionanti, sono l’«occasione», si configurano come «maniera del compiersi» di un’azione; ma l’azione non è detto che sia «necessitata» per ciò stesso. Così ragiona con maestria e con saggezza Giorgio Bàrberi Squarotti in un saggio sostanzioso (Il male nella storia, pp. 33-54), al quale fa seguito quello limpidissimo di Gian Franco Grechi, La «Colonna Infame» oggi (pp. 77-91), sulla funzione dell’intellettuale: lo scrittore deve «consolare», ma ciò non comporta, proprio per nulla, tradire la verità storica. «Untori» sarebbero proprio quelli che sorvolano sul «vivere degnamente» (A. Paredi, Di alcuni recenti untori della «Colonna Infame»: Croce, Nicolini, Cordero, pp. 25-31). Sulla lapide della colonna infame dà notizia dettagliata Guido Lopez, Quante colonne infami? (pp. 55-65).
Sul «manzonismo bresciano» fanno il punto Sergio Pautasso, Giovita Scalvini, lettore di Manzoni (pp. 93-110), e Pietro Gibellini, Un filo bresciano per Manzoni (pp. 111-121). Scalvini non sta, tutto, nell’impietosa formula secondo cui nel Manzoni la religione è un «tempio che cuopre i fedeli e l’altare»: egli è il primo grande critico che, superando la metodologia categoriale dei lettori contemporanei, ha colto la «novità» sostanziale e globale de I Promessi Sposi, focalizzando il rapporto tra storia e invenzione. La storia, in quanto mezzo «di pensieri alti e sapienti», si fonda su una visione morale della letteratura, i cui poli in arte, «che tutto vuole vestire d’immagini», sono costituiti dalla dimensione laica dell’obbiettività storica e la dimensione confessionale della religione. Ecco dunque un intervento chiarificatore. Altrettanto nettamente Gibellini fa il quadro delle «simpatie e avversioni» bresciane per il Manzoni e, personalmente, definisce la «genialità» del Lombardo nel fondere in complementarietà e complessità il comico e il tragico.
Le Manifestazioni Bresciane hanno offerto apporti critici anche interessantissimi in Manzoni e il suo impegno civile.
Enzo Noè Girardi, La lirica civile del Manzoni (pp. 5-21), riflettendo sulla «occasionalità», in gran parte annullata nell’«illusione» storica, di molte delle liriche civili e svolgendo una limpida e serrata analisi delle singole composizioni, rileva il dualismo tra rappresentazione (il «sentire») e ideologia (il «meditar»). Esso s’avverte anche nel già maturo Marzo 1821, in cui la Provvidenza spirituale e la provvidenza eudemonologica – quella che si assume a «funzione pubblica» – sono stabilite in prima persona dall’Autore: ideologicamente, la provvidenza è eudemologica. Perché? Chiarissimo: come faceva il poeta a decidere che, nelle intenzioni di Dio, la cacciata degli austriaci equivaleva all’affogamento degli egizi? Basta, dunque, con lo sguainar spade divine pro domo sua: Dio, nella storia, c’entra, ma in modo più vero. Ed è il Cinque maggio. Superato il punto di vista etnico e contingente, il poeta osserva la storia dal punto di vista di Lui, quando è Lui che vuol mettere in campo: Padre di tutte le genti. E «non impegna il Mandante» (p. 18) in giudizi che, per quanto… giudiziosi, sono affare dell’uomo: per cui, molto coerentemente con il «vero storico», nel romanzo il Manzoni ha lasciato la responsabilità dell’«ordine eudemonologico» all’Anonimo e al quadro ideologico secentesco.
Gian Franco Grechi, «II Trionfo della libertà »: il primo momento (pp. 129-136), ci fa avvertiti con chiari riscontri testuali dell’assillo manzoniano per la libertà, mentre Ernesto Travi, La lingua nell’esperienza civile del Manzoni (pp. 249-260), studioso attentissimo alla problematica linguistica del Lombardo, mostra come la lingua, «testimonianza di un frammento storico di una civiltà» (p. 252), sia vista dal Manzoni «custodia di un patrimonio di ‘commercio civile’», una volta che, consacrando le felici invenzioni degli scrittori mediante l’uso, il popolo le fa sue.
Il denso, stringente e logico studio di Giorgio Bàrberi Squarotti, Il saggio sulla Rivoluzione Francese (pp. 23-51), fa il punto sull’antistoricismo manzoniano e sulla sua angolatura morale. E poi è ora di finirla, coll’attribuire plauso incondizionato agli eventi, soltanto perché son riusciti bene. E «l’ipotesi verosimile di uno svolgimento della storia diverso da quello che è stato» (p. 25)? Manzoni guarda anche a questo: la storia chiede un interrogativo anche sulle «potenzialità» delle operazioni accadute. E ciò è consentito, essendo la storia una fattualità posta in essere da quella «possibilità delle possibilità» (Kierkegaard) che è la scelta umana. Manzoni, si sa, della rivoluzione francese studia il «primo errore», quello che, imprimendo sollecitazioni invertibili, si configurerebbe, tuttavia, ancora potenzialmente abortibile. E qui è il punto. Scontato che Manzoni non nega affatto implicazioni situazionali condizionanti, e ammesso, come dal Manzoni medesimo, che l’errore originante è commesso da chi non intenziona per nulla il male conseguente – gli allegri ammazzamenti, per intenderci -, come si fonda il giudizio negativo del Manzoni? Si fonda sul convincimento che, arrivati ad un momento «cruciale», foriero di pur «imprevedibili» – ciò è chiaro – conseguenze gravi e decisive, chiunque, dotato del ben dell’intelletto e a parte il volere buono, è in grado di capire il giusto dall’ingiusto. E qual è, questo discrimen? Ovvio: è il minimum, al di qua del quale non si dà neppure convivenza. È il diritto. Un’obiezione possibile: e se la contestazione verte proprio su quel «diritto costituito», in nome di una legalità nuova, alternativa, migliore? Risposta: è lo stesso. Si ricorrerà a strategie opportune, ma mai scardinando quella basilare fondazione che è la regola del gioco civile. Altrimenti, fate pure – sembra dire il Manzoni -; ma attenti: vi tirate la zappa sui piedi. E non può che giocar d’ironia, a questo punto. Ma è un’ironia dalla cui parte sta tutta la storia reale. E non solo – diciamo noi – della rivoluzione del Terrore. La categoria dell’equità – conclude il critico – negli stessi processi di mutamento sociale e politico non appartiene alla conservazione. Ma alla progressione. E la storia sta, ancora, dandogli ragione.
L’intervento di Mino Martinazzoli, Manzoni e la giustizia (pp. 312-316), che certamente non è l’ultimo arrivato in fatto di diritto, non solo formale ma anche sostanziale, con scioltezza e con perizia conferma i suddetti ammonimenti: occorre «sostituire le buone istituzioni alle cattive» (p. 315), ma, se si ammazza chi non è d’accordo sulle «buone» idee della maggioranza, allora è finita. Anche se lo si fa per il bene dell’umanità.
Il punto di forza dell’intervento di Arnaldo Di Benedetto, Il «Discorso» sulla dominazione longobardica in Italia (pp. 108-128), è l’interpretazione del testo come «indagine sul tristo uso del potere» (p. 117): per cui si possono trarre dalla storia principi generali. Nel caso, questo: «la tentazione di essere ingiusti è in proporzione della facilità, dell’impunità e del profitto».
Prima di focalizzare alcune tematiche peculiari sul Seicento, il Convegno offre un quadro generale dell’ambientazione storica del romanzo. Vi si impegna Franco Molinari, Manzoni e il Seicento (pp. 53-73), con la sua competenza e il suo equilibrio esemplari. L’intervento ruota attorno a tre nuclei problematici: la mentalità con cui Manzoni affronta la rappresentazione del secolo in oggetto, il fluttuare tra storicità e invenzione di alcuni personaggi del romanzo, il quadro sociale ed economico del Seicento lombardo. Sempre razionalissimo in tutto il discorso, Molinari è innovativo soprattutto nell’inscrivere il pensiero filosofico-spirituale del Manzoni nel contesto delle proposte ecclesiologiche del riformismo tardo settecentesco, che ne spiegano sia l’atteggiamento risorgimentale indipendente dalla Gerarchia, sia la scelta degli «umili», fondata ecclesiologicamente come «popolo di Dio». Anche sulla storicità dei personaggi manzoniani il Molinari offre apporti nuovi, in particolare documentando la figura del cardinale con i Sacri Ragionamenti e vedendo in Abbondio il «polo negativo della stanchezza post-tridentina» (p. 59). Nell’insieme, comunque – e ciò vale pure per il quadro socio-economico -, la valutazione storica del Manzoni sul Seicento risulta legata alla stigmatizzazione di matrice illuministica e romantico-risorgimentale. Con tutta la sua parzialità, dunque.
Il «secolo» del romanzo manzoniano è rivisitato intorno ad un aspetto peculiare da Pompeo Giannantonio, Il lavoro nei «Promessi Sposi» (pp. 75-92): Manzoni trasfonde nel romanzo la propria adesione sincera al processo sociale verso la società industriale, muovendosi tuttavia con tutto il travaglio ideologico tra il principio borghese del profitto e l’egualitarismo di ispirazione cristiana. Molto onestamente, e anche rigorosamente, il critico non nasconde che la ferrea dottrina della rigidità delle leggi economiche ha impedito al Manzoni di riflettere sulle implicazioni discriminanti di certi indirizzi economici. A parte Guido Baldi e Luigi Derla, per quanto mi consti, il Giannantonio è lo studioso che, su questo punto, è stato il meno ambiguo: e credo che non gli si possa non dar ragione, sullo specifico, salvo poi stabilire la spinta evangelica del Lombardo su un versante diverso e peculiare. A suo tempo io avanzai l’ipotesi di un «profetismo» dell’«elemosina» francescanamente intesa; e qui anche Giannantonio rinviene una convergenza nell’attività economico-sociale con lo spirito del cristianesimo: la riscoperta del valore umano del lavoro. Concepito in senso «moderno» (industriale) dal Manzoni, il lavoro operaio avrebbe dovuto costituire la base oggettiva, economica per un riconoscimento istituzionale di una condizione paritaria di tutti i cittadini. Alla fin fine, anche la storia di oggi dà ragione a lui. Molto più che ad altri.
Su un caso del Seicento manzoniano riflette Giuseppe Farinelli, La monaca di Manza tra storia e letteratura (pp. 93-108), già noto per la trascrizione degli atti processuali contro l’Osio (cfr. Vita e processo di suor Virginia de Leyva monaca di Manza, Garzanti, 1985).
Una serie di studi guarda ovviamente a Brescia, tra contemporanei del Manzoni e suoi successivi critici: Bortolo Martinelli, II Manzoni e la cerchia degli amici bresciani (pp. 137-215), con a capo il Pagani, di cui lo studioso ripercorre esaurientemente e approfonditamente i rapporti letterari; Fabio Danelon, Giovita Scalvini lettore dei «Promessi Sposi» (pp. 217-235), utilissimo perché svela le «note» di Scalvini al romanzo e ne coglie l’operazione di fondo nel superare «lo steccato fra laici e cattolici all’interno del mondo risorgimentale italiano» (p. 222); Paolo Paolini, Apollonio e Manzoni (pp. 237-247); Nicoletta De Vecchi Pellati, Le Prefazioni di Camillo Ugoni alle tragedie manzoniane (pp. 261-276), che dimostra come l’Ugoni non abbia colto i fondamenti teoretici del discorso manzoniano.
Un argomento a parte è quello di Paolo Bosisio, II Manzoni drammaturgo dal «Carmagnola» all’«Adelchi» (pp. 277-316), che, continuando il saggio precedente sul Carmagnola, ne studia le differenze: la seconda tragedia accentua l’«azione psicologica» e morale, focalizza il tema centrale nella «caduta», illuminata dalla speranza cristiana, identifica il contrasto fra oppressori e oppressi – tematica anche del romanzo – e trasforma i Cori in parti integranti del testo (non più «appendici liriche», dunque). Si differenzia inoltre dal Carmagnola nell’uso delle scene – che si adeguano alla coincidenza, allora invalsa, con gli entry ed exit e ripresentando le scene di passaggio per creare il clima psicologico della successiva scena drammatica -, e nel dialogo, che lascia maggiori spazi al monologo e al soliloquio, coerentemente con il tono più psicologico della tragedia. La lingua, poi, è più vicina al parlato nelle parti di azione-movimento ed è più concentrata in quelle di «azione interiore». Due osservazioni conclusive appaiono particolarmente interessanti: la distanza presa dal Manzoni non solo dalla tragedia classicheggiante ma anche dal dramma storico coevo; e il distacco determinato nello spettatore – grazie anche alla musicalità ritmica del verso e all’enjambement – dagli eventi rappresentati, in cui egli è posto a distanza critica (anticipazione dello straniamento brechtiano).
Il XIII Congresso Nazionale Studi Manzoniani, concentrandosi sul «Fermo e Lucia»: il primo romanzo del Manzoni, ha lanciato una sfida alla disattenzione moderna nei confronti del Manzoni. Disattenzione? Sì. A dirlo è Natalino Sapegno nello splendido Discorso inaugurale (pp. 5-13). Letterariamente il «primo romanzo» del Manzoni si colloca in piena innovazione europea di stampo settecentesco – individualizzazione caratteriologica dei personaggi, dialettizzazione sociale, récit filosofico e dimensione della quotidianità -, ma la trascende a sua volta, poiché il dialogo dell’Autore, spostandosi dal contingente all’universale, imprime un’alterità incredibilmente moderna ai personaggi: ed è il ricredersi, lo scoprirsi diversi da come si pensava di essere. È questo il distillato pregnante dell’articolato saggio di Edoardo Villa, Suggestioni di narrativa europea nel «Fermo e Lucia» (pp. 15-33), il quale evidenzia anche l’«europeità» della lingua: non per qualche soluzione particolare, ma per la criteriologia fondamentale, quella d’una lingua recepibile dai più ampi strati della popolazione.
Ma all’aspetto linguistico dedica uno studio peculiare lo specialista Michele Dell’Aquila, Le introduzioni al «Fermo e Lucia» e il groviglio non risolto della lingua (pp. 35-53): incuneata tra due grandi difficoltà, e cioè la documentazione storicamente rigorosa e il rifacimento narrativo, la questione linguistica in Manzoni si annuncia tematicamente attraverso l’ironizzazione dello stile barocco – nella prima Introduzione al Fermo e Lucia -, poi procede attraverso il classico criterio del rem tene, verba sequentur – cioè, della rudimentale, ma pratica, metodica per cui la materia ideata presiede alla selezione lessicologica e all’operazione stilistica -, e infine si organizza nella teoria dell’Uso e del Bisogno: compensazione reciproca tra le imposizioni di una linguistica formata e le esigenze espressive dell’invenzione artistica. Tale ricerca di equazione Uso-Bisogno percorre tutti gli scritti manzoniani e passa attraverso l’eclettismo del Fermo e Lucia, proiettandosi tuttavia, caparbiamente, verso la teoria della intelligibilità, per allargare al massimo la fascia dei lettori. Tale principio agirà anche nella fase più fiorentina della risciacquatura – operazione, del resto, ispirata al suddetto fine anch’essa -: pur sempre con innesti creativi (per il Bisogno!) di notevole ardimento.
Ma poiché la ricerca linguistica manzoniana è anche in ordine alla rappresentazione degli uomini nel loro responsabile rapporto con se stessi, con i propri simili e con la storia, ecco che il romanziere si pone il problema di come intrecciare il racconto (la «trama») con la presa di coscienza dell’operare, dell’optare, del giudicare, sia da parte dei personaggi, sia da parte dello scrittore, sia da parte di quell’impiccione che si mette in mezzo dappertutto – ma ne ha ben diritto! -, che è l’Anonimo. La soluzione nel Fermo e Lucia è la «digressione» – ne tratterà Bàrberi Squarotti -, di diversa natura e spessore: può essere commento dell’autore, può essere analisi che diventa racconto essa stessa nell’offrire elementi costitutivi dei personaggi, può essere esplicitazione dell’indistinto del loro animo. Ne deriva una conseguenza dal punto di vista temporale: il tempo della narrazione si dilata, «indugia» (p. 61), gradua i momenti in un minuzioso «prima» e «poi». E, in definitiva, per ciò stesso si avvicina al tempo narrato. Questa è l’interessante angolatura ermeneutica di Claudio Varese, «Fermo e Lucia»: analisi, tempo e racconto (pp. 55-73), il quale investiga l’intreccio strutturale con esemplificazioni testuali di grande finezza.
Sull’importanza delle digressioni, che costituiscono un vero «romanzo nel romanzo», riflette con analisi dei brani e con interpretazione globale Giorgio Bàrberi Squarotti, La metaletteratura nel «Fermo e Lucia» (pp. 139-182). Innanzitutto: a quale strategia obbedisce la digressione? A quella di consentire al narratore di «tutto giudicare dal di fuori» (p. 166). Qual è il fondamento narratologico? È il «personaggio ideale» – così Manzoni -, cioè un ipotetico «lettore-critico», figura interlocutoria extra-diegetica, oggettivata al massimo «in modi narrativi, compreso il dialogo» (p. 147) – lo ha avvertito anche Claudio Varese. E fin qui, nulla di speciale. Ma quale il ruolo della digressione nell’economia generale del racconto? È il riequilibrio meditativo – non definitivo e pacifico, tuttavia, ma problematico, inquieto, dinamico e dialettico – dell’impianto libero, aspro, quasi acre e violento del Fermo e Lucia. Non è piaciuto a Goethe. Ma con Goethe o senza Goethe, la domanda da porsi non è se il risultato sia «bello» o «brutto», bensì il seguente: quale idea della letteratura sottende alla stesura del Fermo e Lucia? E qui il critico penetra nella sostanza: è l’idea che la letteratura è essenzialmente opera costituita da idee. Ecco dunque: le digressioni, dialogiche o disquisitive che siano, si intrinsecano nell’opera d’arte. D’accordo. Però il problema non è risolto affatto, dal punto di vista teoretico. Anzi s’aggrava. Perché? Perché se l’opera letteraria si costituisce essenzialmente di idee, e se le idee si materializzassero fondamentalmente in osservazioni e analisi «saggistiche», allora il passaggio a I Promessi Sposi – in cui, si sa, commento e valutazione si compattano di più con il narrato – sarebbe un regresso. Ed è falso. Anche a ciò il critico dà la risposta. Innanzitutto il Fermo e Lucia è un romanzo, si può affermare, a sé stante, e poi bisogna dire che tale autonomia «inventiva», in cui si giustificano le «virgolettature» digressive, rispondono a una necessità congiunturale di definire alcuni problemi scottanti e pregiudiziali all’epoca della stesura. E così si capisce che la configurazione saggistica delle idee non assurge a forma sostanziale dell’opera letteraria, ma ne rappresenta un modulo accidentalmente esigito, che acquista fantasia poetica sotto due riguardi: l’uno soggettivo e ispirativo, quand’«è l’amore che mi fa parlare», dantescamente, e l’altro oggettivo e narratologico, grazie al gioco di intersecazioni tra extradiegetico e diegetico ed al connubio di sorriso e d’ironia (di cui già molti critici han parlato). Quali siano le problematiche assillanti a cui il romanziere si sentiva anche poeticamente di doversi accostare, Bàrberi Squarotti lo dice esaminando le digressioni: la lingua, il concetto di letteratura come utilità morale e non già come diletto, dunque l’esclusione dei temi eroici nel senso della crudeltà dei potenti e, invece, la dipintura delle «virtù private». Pur acuto in tutte le disamine, Bàrberi Squarotti mi sembra particolarmente felice in una intuizione che mi par nuova del tutto: a proposito della famosa digressione sull’amore in letteratura, egli non solo segnala lo spirito di tolleranza del Manzoni – il romanziere protesta di parlare «per sé», senza «emettere sentenze» (p. 152) -, ma scorge potentemente un terzo tipo di lettore. Non c’è soltanto quello «ideale», né solo quello reale che legge. Ce n’è un altro: quello reale che legge il non detto. Ciò non va inteso, si badi, nel senso di Arbasino: per il quale il «non detto» è offerto in succulento pasto dallo scrittore malizioso mediante la preteriezione eccitante. Va inteso, invece, nel senso di un vero e proprio rapporto di interlocuzione fantastica tra il «non dicente» che si sa letto e il «non leggente», nel presupposto che quest’ultimo sappia, sì, il contenuto censurato, ma comunichi pure circa il senso della censura sul contenuto. Una forma di celeste armonia d’amorosi sensi? Sì. Che ben conosce chi l’ha sperimentata.
Fatti i conti in tasca al Manzoni, alla fin fine la letteratura più vera è quella agiografica. Lo afferma Bàrberi Squarotti. Abbastanza scontato. Ma non è per nulla vieto quel che egli aggiunge: che i santi servono per la crescita morale della gente, non se ammirati come dei Curi o dei Fabrizi «romani», ma se inseguiti nella loro tremendità di catarsi e di metànoia. Sta di fatto che i «santi», nel romanzo, insegnano a vincere se stessi. Tutti. Salvo uno: di cui si sa della vittoria, si sa dove è giunto, non si vede che sta camminando. È don Serafino Morazzone, curato di Chiuso (Milano 1747 – Chiuso 1822), espunto nella seconda stesura del romanzo. Ne parla Antonia Mazza, Il curato di Chiuso: problemi agiografici e poetici (pp. 75-89), delineandone la figura storica e l’iter dei processi informativi ecclesiastici. Quella del Manzoni, che lo conobbe, come dimostra una lettera del prete allo stesso Manzoni, costituisce umanamente una «testimonianza di virtù» accanto a quella dei biografi del «servo di Dio»; poeticamente, il «rovescio» di don Abbondio secondo il rilievo delle Osservazioni sulla morale cattolica, accostabile testualmente al brano del Fermo e Lucia circa la «bellezza-felicità» che la religione cristiana, se praticata bene, conferirebbe alla vita. Ma allora, perché è stato espunto, questo oleografico quadro del «pio»? Forse, appunto, perché oleografico? Può darsi. Il motivo più plausibile, comunque, sembra da rinvenire nell’anacronismo tra una figura storica dell’Ottocento e l’ambientazione storica del Seicento. A proposito del Cristoforo manzoniano, Giuseppe Santarelli nel 1970-1971, negandone la storicità come «individuo», concludeva con la medesima considerazione. Resta comunque assodato che il curato di Chiuso rappresenta una prova della predilezione manzoniana per la nascosta grandezza degli «umili» e della diffidenza per le azioni grandi ed eroiche.
Sulla ricerca della verità storica nel Manzoni incentra il suo studio Mario Sansone, «Fermo e Lucia»: le parti stanche (pp. 119-133). La preoccupazione della verità storica nella sua assolutezza investe in modo pregnante il Manzoni al tempo dell’Adelchi, quando egli intende recuperare alla storia proprio gli avvenimenti di coloro che passano nel mondo obliati dalla «Storia»: come garantire con verità ciò che non è documentato? L’assillo insegue il Manzoni nel Fermo e Lucia, un’opera concepita come «complemento della storia» (p. 126), tanto che il romanziere ha in mente di produrre i documenti consultati («note di libri, memorie et cetera»), sfidando consapevolmente i lettori scettici. Pur tuttavia egli deve ripiegare, al momento, su una metodologia provvisoria fondata sul deviner, realizzando esaustivamente, così, la poetica della Lettre e al contempo avanzando in una «autoesperienza» orientata verso il discorso Del romanzo storico. Intanto nel Fermo e Lucia la storicità va vista come rappresentazione globale dei costumi di un’epoca, con intima connessione non solo tra le «copie» dei documenti e le analisi storiche, ma anche tra l’invenzione fantastica e le «parti» storiche medesime: due «forme di narrazione» che si giustificano vicendevolmente. E qui va anzi osservata la particolare sequenza tra documentazione, analisi e invenzione: le parti inventate precedono, poi seguono le documentazioni, infine procede l’indagine propriamente storiografica (p. 128).
L’«anteriorità», nel senso dell’anticipazione, della storia inventata rispetto al documento è rilevata da Gianfranco Vigorelli a proposito di un episodio specifico, La monaca di Monza: dal «romanzo» al «documento» (pp. 91-101): la capacità di divinare, per così esprimerci, la realtà dei fatti concorre a dimostrare quella vocazione storiografica del Manzoni che non soltanto riguarda l’impegno, ma anche investe l’istinto.
Della Geltrude della prima stesura manzoniana si occupa specificamente Umberto Colombo, La monaca di Monza nel «Fermo e Lucia» (pp. 183-214): una storia «nera», che si nutre di «paura» conscia ed inconscia. La novità critica di Umberto Colombo sta nell’individuare il motivo artistico ed etico dell’espunzione di gran parte di quella storia. Poiché lo «spettacolo interessante» in arte – sostiene il Manzoni – è il conflitto dell’io con se stesso, e non può essere che questo, qualora la guerra concerni la morale, allora, nel momento in cui la lotta è terminata e «la coscienza è vinta», viene a mancare la sostanza della «storia» individuale al di là della cronaca, cioè delle resistenze estrinseche al proprio spirito: «II dramma di Geltrude non è nei delitti, bensì nell’interna lotta da cui esce sconfitta» (p. 191). Nel Fermo e Lucia l’autore applica il criterio di rappresentare il male – nei «perché», non nei «modi» – per inculcare il «disgusto del male»; ne I Promessi Sposi applicherà lo stesso criterio, ma in maniera più rigorosa, perché lascia sussistere, nell’epigrafico «rispondere», il consentimento al peccato, senza tuttavia mostrare come si possa «confezionare» il peccato. Un ulteriore apporto critico del Colombo è l’individuazione di nuove fonti sulla monacazione forzata con le sue implicazioni familiari e sociali: l’Histoire des républiques italiennes del Sismondi e il Cicerone di Gian Carlo Passeroni.
In un riflesso speculare, sintetizzabile nell’epigrafica: «Lucia arrossì», che consuona misteriosamente con: «La sventurata rispose», la monaca di Monza è osservata da Lorenzo Mondo, Lucia e Gertrude allo specchio (pp. 215-223). Il rifrangersi speculare è ben focalizzato dal critico, che per di più scorge – ed è questa l’analisi originale – una convergenza interlocutoria tra Lucia e la monaca: «un fiotto di solidarietà» (p. 219) trapassa tra i due personaggi, vittime eguali di un diseguale destino. Su questo registro ermeneutico il Mondo conduce una serrata disamina convincente. Si potrebbe aggiungere la specularità tra l’atteggiamento di Geltrude-Gertrude verso il padre guardiano e quello di Lucia verso il padre Cristoforo; o tra la piega esistenziale della monaca, nelle forzate condizioni di vita, e quella di Lucia – è il romanziere che in prima persona s’introduce con una famosa considerazione – e così via. Ad ogni modo è bello che ogni studioso aggiunga qualcosa di nuovo, non potendo ciascuno esaurire tutto.
Intorno ad un altro personaggio storico, Federico Borromeo, Gian Franco Grechi, «Aiutarli a portare la croce del genio» (pp. 135-138), riflette circa la frase, di cui nel titolo, espunta nella seconda stesura del romanzo ed interna all’osservazione manzoniana sulla scarsa risonanza degli scritti del cardinale, il quale si rammaricava per non potersi dedicare completamente all’attività letteraria, ritenuta foriera di fama presso i posteri. Certamente è un’annotazione autobiografica, proiettata sul personaggio; ma l’apparente contraddizione nasce nel confronto con l’assunto manzoniano, secondo cui il fine dell’arte non è la gratificazione del proprio genio-ingenium. Il critico la risolve distinguendo tra intenti di bene, come quelli dell’arcivescovo, e intenti puramente egoistici – come quelli di un Cesare Coen -, e rispettivamente tra contenuti morali della letteratura e contenuti profani. Nel caso del suo cardinale, il Manzoni giustifica il rammarico. Oltre a ciò, potrebbero vedersi insinuate altre ragioni, tuttavia. Il Manzoni, per un verso, potrebbe ironizzare sottilmente, sapendo che, nel prosieguo storico almeno fino a lui, i libri del Borromeo non avrebbero proprio per niente consacrato la sua fama, neppure con un centinaio di editi; per altro verso offrirebbe un autentico insegnamento evangelico: Dio, spesso, si serve dell’uomo non attraverso ciò che l’uomo ha in animo di fare, ma attraverso ciò che l’uomo non vorrebbe fare.
L’indagine critica si sposta ora su due aspetti peculiari, studiati tuttavia nella globalità del pensiero manzoniano: lo «spazio», non escluso quello sociologico e quello economico, e la «carestia». Sulla polisignificanza dello spazio nell’opera manzoniana svolge una rigorosa e puntuale investigazione Franco Lanza, II paesaggio di «Fermo e Lucia» (pp. 103-118), il quale fa il punto sul realismo ideologico della natura nel romanzo: essa non è necessariamente la «bella natura» della fantasia, ma può essere il segno di una disarticolazione tra la realtà del mondo e la realtà dell’animo. Altrettanto, può esserci uno iato tra storia e provvidenza, tra storia domestica e storia collettiva: Manzoni non è leibnizianamente ottimistico né vichianamente sicuro che la provvidenza sia «impastata» con le evoluzioni – presunte o meno – della storia. Chi ha il privilegio di filtrare il paesaggio, in tutti i suoi significati, alla luce di una visione superiore, è Lucia, la cui purezza di cuore può passare dallo sguardo lirico alla percezione «diagnostica» del bene e del male, della sincerità e della malizia, mentre Fermo, emblema dell’animo ardente nel Fermo e Lucia, brucia il paesaggio che di volta in volta gli si affaccia nella vita.
Pure dallo spazio umano, che si fa storia, prende avvio Folco Portinari, Tra il grano e la fame (pp. 225-235): la «ruralità» del Fermo e Lucia – «sottogenere rusticale» che ne anticipa largamente i «più tardi e riconosciuti cultori» – va collocata all’interno dell’idea politica che denuncia la sopraffazione, sia giuridica, sia economica. L’«assoluzione» manzoniana dei deboli va al di là della semplice comprensione: il perno del romanzo gira attorno, in sostanza, al bisogno di vivere e ai mezzi per soddisfarlo. Il diagramma della carestia lo rende chiaro. Certo, i rimedi proposti dal Lombardo contengono complicazioni, ma è rilevante che il concetto stesso di provvidenza «è continuamente corretto nel senso della previdenza» (p. 235).
Oltre che sul «primo romanzo» manzoniano, il CNSM cerca di portare ulteriore luce sui Promessi Sposi in Letture Manzoniane, con prospettiva di «informazione e di formazione» (Giancarlo Vigorelli, La ripresa delle «Letture Manzoniane» e oltre, pp. 5-10). Edoardo Villa, Don Ferrante o la genialità del concreto (pp. 11-24), «leggendo» il cap. XXVII delinea l’abbozzo, in un domicilio privato, dei costumi e della cultura secenteschi attraverso l’intermezzo descrittivo-caricaturale di don Ferrante. Del cap. III Sergio Pautasso, L’Azzecca-garbugli e il dispregio della parola (pp. 25-33), studia la potente ironia manzoniana, questa volta non soltanto scherzosa: perché ne va di mezzo la giustizia. E allora la pagina graffiante si fa drammatica ed etica nell’accostamento narrativo con l’immagine contraddicente di Cristoforo e con l’inserimento di fra Galdino, dalla parola edificatoria ma non ingannatrice.
Su una pausa narrativa del cap. XXX si sofferma Geno Pampaloni, Dove si scopre un don Abbonalo solitario e infelice (pp. 35-48), un Abbondio coraggiosamente in fuga. E sì, perché il coraggio ce l’ha da vendere, quando si tratta d’aver «paura»! È qui che il «lettore» entra nell’animo del curato: la paura di don Abbondio non è per niente disgustosa, perché è in lui un tratto esistenziale, che gli «deforma» addirittura la vista del reale in una «autoalienazione per eccesso e metastasi di egoismo» (p. 45). Ne è prova il fatto che egli non «soffre» mai: egli scansa. Oppure se la prende con gli altri. Non ha dolore: ha trepidazione. Non conosce cordialità: solo diffidenza. Per questo non è stato condannato: alla fin fine, egli è un uomo solitario. Terribilmente. E malinconico. Sotto un’altra angolatura, quella etica, la pavidità donabbondiana è sviscerata da Umberto Colombo, Il torto di chi fa pasticci (pp. 49-70): è la frase, nel cap. I, con cui il curato, per scusarsi con i bravi di don Rodrigo, addossa la colpa su quelli che si volevano sposare. Nella seconda stesura il romanziere ha cambiato il termine «aggiustamenti», che corrisponde nel dialetto milanese a «pattuizioni nuziali», con quel vigliacchissimo altro termine: come a dire che, per don Abbondio, la colpa è di chi s’innamora! La prognosi morale è disperata. Le iniziali analisi del Colombo dimostrano che lo scenario paesaggistico, con cui il romanzo si apre, non è uno sfoggio topo-geografico, ma una fine ambientazione dell’attitudine al «domestico» del curato, alla quale rimanda una natura confidente e conosciuta, entro cui deflagra come un fulmine lo sguardo terrificato, che s’imbatte sui brutti ceffi. Anzi, bruttissimi. E a nulla vale la preghiera del salmista: «Se mi troverò nei guai, tu mi darai la forza, o Dio!». Meglio non rischiare: «troppo giusti, troppo ragionevoli…». Carattere opposto è quello dell’Innominato, fegatoso nel violentare e nel beneficare. Ne parla Stefano Jacomuzzi, «In man recando il prezzo del perdono» (pp. 70-88), sottolineando già nel titolo la collocazione semantica del «perdono» nella storia della Grazia in senso stretto. Le microvarianti narrative e lessicologiche tra il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi (capp. XX-XIV) svelano che «perdono» e «misericordia» acquistano un nesso intrinseco in riferimento non già ai processi psicologici, vuoi dell’Innominato, vuoi di Lucia che gli sta di fronte, ma alla tensione teologale, a cui tutto l’affresco della conversione rimanda. L’analisi del critico è particolareggiata, viva e concettualmente puntuale, concludendo con un rilievo anche teologico: il «pegno del perdono», assunto in proprio dal Conte del Sagrato di ritorno al castello, nei Promessi Sposi gli viene invece attribuito da un altro (dal cardinale), come a significare l’interdipendenza «strumentale» degli uomini in rapporto all’unica fonte di carità, che discende dal «Padre di ogni misericordia». Infine, ecco il significato generale del romanzo, davvero «senza idillio» se, realizzato il «sogno», iniziano i guai normali: che neppure val la pena raccontare. Non «scadimento», dunque, ma «mimesi» della vita è il cap. XXXVIII, spiegato da Pietro Gibellini, L’ultimo capitolo: parabola del romanzo e romanzo-parabola (pp. 88-102). A questo punto, al romanziere sembra che interessi di più riflettere, magari sotto l’apparenza di un conversar domestico, che non immaginar storielle appiccicate alle costole di mamme, papa, figli e consanguinei; e fra le tante saggezze c’è il «bilancio». Ognuno ricuce la propria parabola. Salvo Abbondio, il quale, straripante di macchiettismo, è restato al punto di partenza, con quel beato De profundis per Rodrigo. Per Fermo-Renzo l’iter è stato «di formazione» eticamente ragionevole, sulla quale lei, la mulier dulce ridens, getta l’ultimo sguardo dolce e ieratico: i guai son proprio essi a venire incontro a noi; ma le parole del Signore sono consolazione e forza. Per me.
Tra i meriti del CNSM si annovera, come è giusto, la pubblicazione di scritti manzoniani anche «secondari»: seppur ci siano – avverte il Bezzola nella Prefazione – scritti manzoniani così «minori» da non esser rilevanti. Ma perché la prima stesura della Lettre riveste tanta importanza? Sul piano dell’atteggiamento intellettuale, perché documenta la tensione alla ricerca continua, che non si ferma ai primi assunti ma procede indagando ed evolvendosi. Sul piano testuale, perché tra il «primo sbozzo» e l’edizione a stampa si nota nell’Autore l’inquieta consultazione di se stesso per una piena consapevolezza della poetica del «vero». La monografia si struttura in un lungo capitolo di Umberto Colombo, Storia della «Lettre» (pp. 9-38), sulla vicenda concreta del testo, in una Nota filologica di Aldo Rosellini (pp. 39-47) e nello scritto manzoniano stesso, Primo sbozzo della «Lettre a M. Chauvet» (pp. 51-110), curato dal Rossellini e tradotto dal Colombo, Guida alla lettura del testo francese (pp. 113-135), terminando con l’indice dei nomi, un apparato editoriale sempre prezioso.
La storia della Lettre a Victor Chauvet, un critico personalmente non conosciuto dal Manzoni, molto probabilmente nacque da un invito di Charles Loyson – autore di un’Ode al Manzoni – rivolto allo Chauvet, perché intervenisse a proposito del Conte di Carmagnola. Alla recensione, edita nel maggio 1820 sul «Lycée Francais», il Manzoni rispose con la Lettre. Lasciando anticipatamente Parigi alla fine di luglio del 1820, Manzoni affidò la Lettre al Fauriel, sollecitandone l’immediata pubblicazione, ma poi, nei primi due mesi del 1821, con due lettere vi si oppose decisamente; però, nel novembre dello stesso anno s’augurava che la Lettre fosse già edita. Ma quale Lettre? Indubbiamente, non quella iniziale, «sbozzata». Si trattava di un ulteriore testo, riscritto e modificato: insomma, di una «copia», cui faceva riferimento il Manzoni al Fauriel discutendo sulle variazioni da apportarvi (lettere del 29 marzo 1822, del 29 maggio 1822, del 12 settembre 1822, del 10 dicembre 1822), e cioè di una seconda stesura. A livello testuale lo dimostrano le differenze riscontrabili tra il suddetto «sbozzo», la copia inviata alla Censura e l’edizione a stampa. La seconda stesura della Lettre, «quasi» definitiva, è collocabile prima del novembre 1821 – quando il Manzoni chiedeva al Fauriel se la Lettre fosse stata già pubblicata -, e addirittura entro la fine di luglio del medesimo anno – data del rientro del Manzoni in Italia. Infatti, Manzoni testimoniò ad Alfonso Della Valle di Casanova (30 marzo 1871) di aver scritto la «dissertazione» nel 1820; la medesima notizia si ricava dall’Avertissement del Fauriel e da Saint-Beuve. Orbene, il testo da pubblicare non poteva essere lo «sbozzo», sia perché l’indicazione manzoniana su tale manoscritto dice testualmente: «La Copia che deve servire alla stampa è presso Fauriel», sia perché il detto «sbozzo» conteneva tanti segni di ulteriori svolgimenti, come etc.». Tra le carte del Fauriel – ora all’«Institut de France» – si conservano due pagine della Lettre di mano manzoniana: esse fanno proprio pensare che appartenessero alla seconda stesura parigina. Tra gli altri indizi ci sono le varianti a dimostrarlo: varianti che non trovano paralleli nello «sbozzo», mentre sono confrontabili con il testo della copia per la Censura e con l’edito.
Ma come mai tanto tempo dalla copia, quasi completa, all’edizione, se la copia sostanzialmente definitiva era già presso il Fauriel nel 1820? – L’edizione è del febbraio 1823. Perché tanti tentennamenti, nel Manzoni, che prima è impaziente, poi s’oppone e di nuovo è in attesa della pubblicazione? Son problemi aperti. Resta comunque certo che il rifacimento complessivo della Lettre ha come termine estremo il novembre 1821 e che le modifiche apportate al testo (della seconda stesura) non sono attribuibili al solo Fauriel. In definitiva, noi oggi abbiamo uno «sbozzo» della Lettre redazionalmente analogo a quello che è stato il Fermo e Lucia; abbiamo una copia-censura e un testo a stampa, paragonabili alla Ventisettana e alla Quarantana del romanzo. E lo «sbozzo», in effetti, ha un’impostazione molto diversa dalla stesura successiva. Esso segue passo passo la recensione dello Chauvet – come appunto viene spontaneo fare, quando si ha un preciso testo sul quale discutere -, enucleando sostanzialmente i cardini ideologici e poetici del Romanticismo, mentre la seconda stesura si slarga secondo la passione di un intellettuale impegnato intorno a vivaci problematiche, quali la distinzione del ruolo del poeta e dello scrittore, la funzione dell’amore in letteratura, i doveri dello scrittore, ecc. Con la Lettre noi, a posteriori, vediamo iniziato il cammino manzoniano verso la poetica del «vero»: dal principio della «libera» creatività anticlassicistica – in un recuperato «Amor mi spira… e a quel modo ch’e’ ditta dentro», già dantesco – alla poetica del «vero» che presiede alle grandi opere, fino alla sua fondazione metafisica del dialogo Dell’invenzione. E non c’è contraddizione: ma connessione. Perché l’interiorità libera del poeta non è fantasticare, ma «pensare»: «comprendere», cioè, ciò che l’uomo è, quale la sua «natura» e la coscienza.
La Nota filologica offre poi i dati d’archivio del manoscritto e indica i criteri della trascrizione. Non li riferisco, per non ricopiare oziosamente quello che pazientemente il Rosellini ha svolto. Mi piace notare invece un’osservazione sulla preziosità delle minute d’autore, quelle in cui si può scoprire l’idea che attraversava la mente mentre lo scrittore vergava una parola. E già, perché a volte la testa è più lesta della mano e «le parole – dice il Manzoni – sono più ritrose e intrattabili delle cose». [Francesco Di Ciaccia]

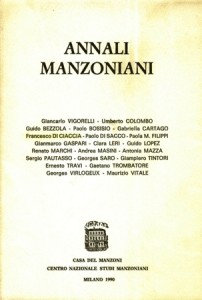
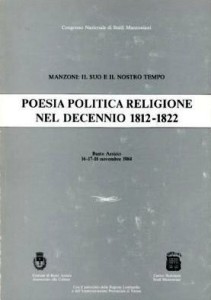
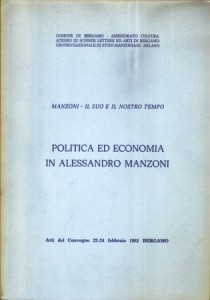





Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.